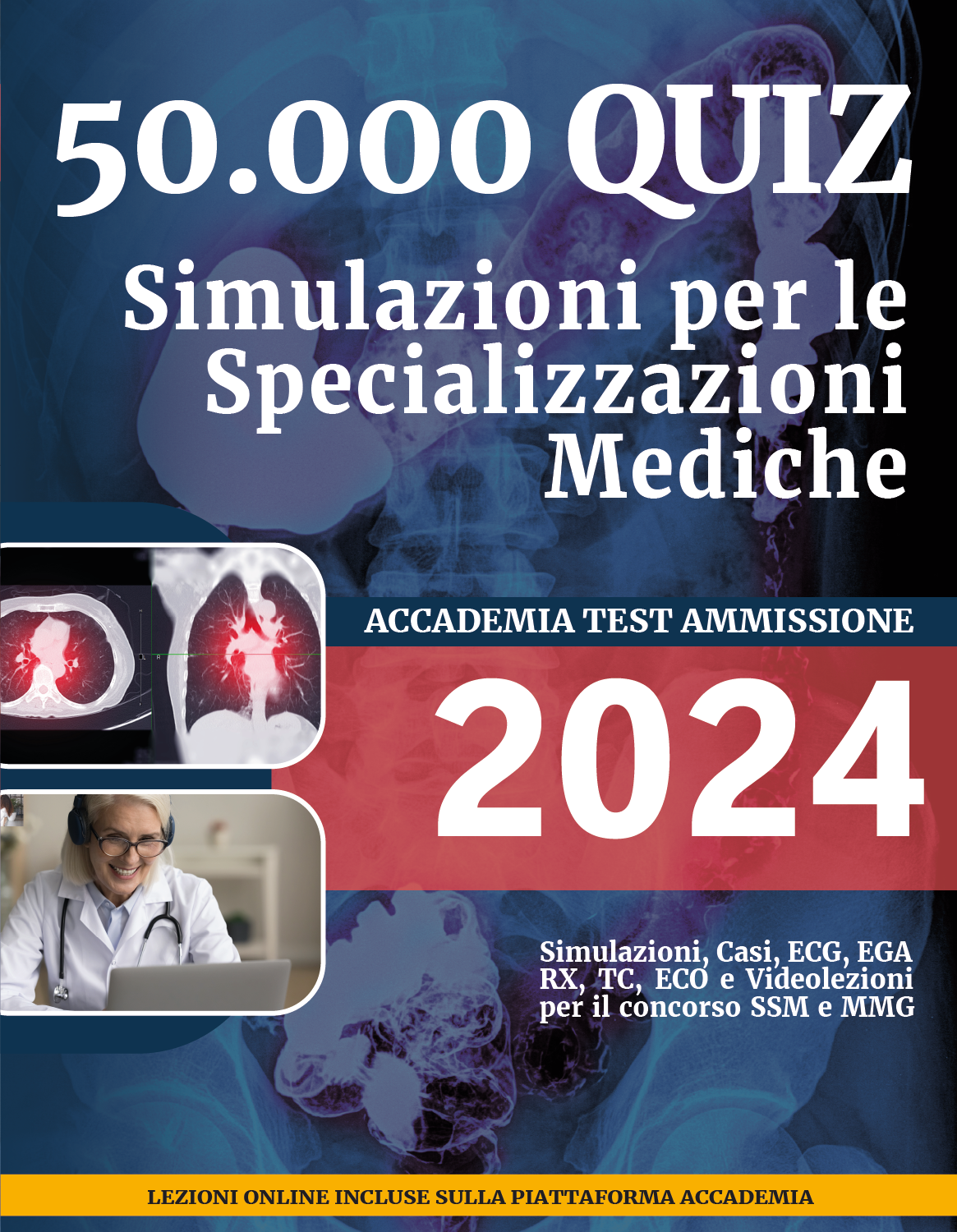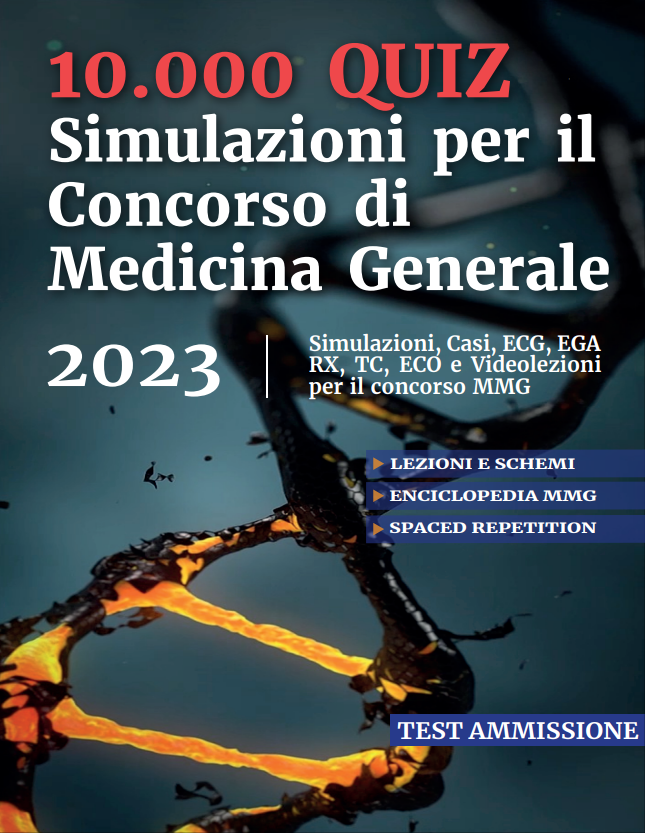La risposta corretta è la B.
I norovirus (conosciuti anche come virus di Norwalk) fanno parte della famiglia dei Caliciviridae e sono dei virus a singolo filamento di RNA.
Il Norovirus infetta più frequentemente i bambini più grandi e gli adulti e le infezioni si verificano durante tutto l’anno, con il picco di incidenza da novembre ad aprile.
La trasmissione avviene prevalentemente per via oro-fecale (attraverso l’ingestione di acqua o cibo contaminato), anche se talvolta la diffusione può avvenire anche per contatto (con superfici contaminate).
Il periodo di incubazione del virus va dalle 12-48 ore, mentre l’infezione dura in media da 1 a 3 giorni.
I sintomi sono quelli comuni alle gastroenteriti e cioè nausea, vomito ad insorgenza acuta, crampi addominali, diarrea acquosa non sanguinolenta. In qualche caso si manifesta anche una leggera febbre.
La malattia solitamente ha decorso favorevole con risoluzione spontanea e necessita solamente di una terapia di supporto: infatti l’unica misura è quella di assumere molti liquidi per compensare la disidratazione conseguente a vomito e diarrea.
Pertanto visto che i norovirus vengono transmessi attraverso il circuito oro-fecale e vista la sintomatologia sovrapponibile al quadro clinico presentato nel caso, Grazia ha probabilmente contratto l’infezione da Norovirus in seguito all’ingestione di cibo o acqua contaminati.
La risposta A non è corretta.
Lo Staphylococcus aureus è un patogeno comune che causa tossinfezioni alimentari, in seguito all’ingestione di esotossine preformate che lo S.aureus produce in alimenti contaminati (per esempio carne in scatola, maionese). Gli stafilococchi sono batteri aerobi Gram-positivi. Lo Staphylococcus aureus è il germe a maggior patogenicità, responsabile di infezioni della pelle, endocardiche, polmonari, gastrointestinali, delle vie urinarie e di osteomielite. Alcuni ceppi sono produttori di tossine e sono responsabili di gastroenteriti, della sindrome della cute ustionata e della sindrome da shock tossico. Nel caso di tossinfezioni alimentari lo S.aureus generalmente causa sintomi a rapida insorgenza,come nausea e vomito, già dopo 1-3 ore in seguito all’ingestione degli alimenti infetti, mentre la paziente presenta nel caso mostra come sintomo predominante la diarrea e i suoi sintomi sono iniziati due giorni dopo essere stata a cena fuori.
La risposta E non è corretta.
I Rotavirus sono Virus a RNA responsabili di una malattia diffusa in tutto il mondo e sono la causa più comune di gastroenteriti virali fra i neonati e i bambini al di sotto dei 5 anni: nelle diverse età e nei diversi paesi, in via di sviluppo e cosiddetti sviluppati, le cause della gastroenterite nei bambini sono causate in grandissima parte da questo virus. I rotavirus hanno un andamento sporadico, prevalentemente in inverno nei bambini molto piccoli, che si trasmettono prevalentemente per via oro-fecale (attraverso l’ingestione di acqua o cibo contaminato), anche se talvolta la diffusione può avvenire anche per contatto (con superfici contaminate) e per via respiratoria.
Le gastroenteriti da rotavirus si manifestano con vomito, diarrea e malessere generale, sintomi che insorgono dopo un periodo di incubazione di 1–3 giorni. Tuttavia, tipicamente si manifesta anche con febbre, diarrea acquosa molto severa (> 10 scariche di diarrea acquosa entro le 24 ore) e disidratazione: pertanto vista la maggiore prevalenza di questa infezione nella fascia neonatale ed infantile e tenuto conto del differente quadro clinico possiamo escludere tale diagnosi nel caso presentato.
La risposta D non è corretta.
Escherichia coli è una delle numerose specie batteriche di cui è composta la normale flora intestinale.
E. Coli è un batterio che appartiene alla famiglia degli enterobatteri, è un Gram-negativo, asporigeno, mobile per ciglia peritriche, catalasi positivo e ossidasi negativo.
Il fatto di essere un Gram-negativo, rende questa risposta l’unica possibile corretta.
I diversi ceppi possono essere classificati sulla base di tre principali antigeni di superficie: somatico (antigene O), flagellare (antigene H), capsulare (antigene K).
Nell’ambito della specie sono presenti diversi ceppi dotati di fattori di virulenza e associati a ben definite patologie sia intestinali che extra-intestinali:
– E. Coli enterotossigeno, acronimo ETEC
– E. Coli enteroinvasivo, EIEC
– E. Coli enteropatogeno, EPEC
– E. Coli enteroaderente, EAEC
– E. Coli produttore di verotossine, VTEC
– E. Coli enteroemorragico, EHEC (ceppi enteroemorragici sono un sottogruppo dei VTEC)
I ceppi di E. coli enterotossigeno (ETEC) sono la causa più comune della cosiddetta diarrea del viaggiatore, che si può contrarre viaggiando in paesi o regioni in cui vi sono condizioni igieniche precarie delle acque e degli alimenti. L’infezione da ETEC può anche causare diarrea acquosa, crampi addominali, nausea, e possibile vomito dopo un periodo di incubazione che va dalle 9 ore ai 3 giorni e il trattamento di questa infezione si effettua con un breve ciclo di ciprofloxacina. Tuttavia la paziente riferisce di non avere effettuato viaggi recentemente, pertanto tali ipotesi è poco probabile.
La risposta C non è corretta.
La salmonella è ampiamente presente in natura e sono localizzate prevalentemente nel tratto gastrointestinale di molti mammiferi, sono batteri gram-negativi, asporigeni mobili e catalasi positiva(il diverso tipo di catalasi può essere correlato alla diversa sierovariante della salmonella e permette una precoce identificazione delle stesse). Possono essere riconosciute attraverso l’antigene O (somatico), l’antigene H (ciliare o flagellare) e l’antigene V di minore importanza.
Fanno parte della famiglia delle enterobacteriaceae, sono mobili anche se si hanno varianti non flagellate, sono ubiquitarie e sono a trasmissione oro-fecale, le famose “4 F” ossia: fingers, flies, food e feces (dita, mosche, cibo e feci).
Il reservoir primario è nel tratto intestinale degli animali, ma anche nei polli (soprattutto per le salmonellosi minori), carni (suine e bovine), pesci, frutta e verdura ed acqua; presente anche in molti generi alimentari come uova, maionese, formaggio, gelati e cereali per la prima colazione.
Soprattutto nella salmonellosi umana ci sono dei portatori, dei carrier che sono dei portatori sani che emettono la salmonella a livello di un organo difficile da raggiungere e bonificare che è la colecisti.
Parlando di Salmonella enteridis stiamo parlando di salmonellosi minori, quindi non di forme setticemiche ma di forme enterocolitiche, di sovrainfezioni acute, che spesso non necessitano di alcuna terapia.
Seguiamo la Salmonella enteritidis che è una delle maggiori nell’ambito delle minori. Abbiamo un’ingestione, l’assorbimento, anche qui attraverso questi cancelli, riconosciuti a livello intestinale, abbiamo una migrazione all’interno della lamina propria, specie della regione ileo-cecale, una moltiplicazione a livello del sistema reticolo endoteliale. Abbiamo, però, non il passaggio nel sangue, in genere. Abbiamo un passaggio, un reclutamento di polimorfonucleati che confinano, in qualche modo, lasciano, così, che la lesione resti confinata a livello intestinale e lì darà i sintomi, darà la diarrea.
Ma qual è l’origine della diarrea? L’origine della diarrea è in una risposta infiammatoria, dovuta alla presenza dei germi, che mediano il rilascio delle prostaglandine. Queste stimolano l’AMP-ciclico, il sistema dell’Adenilciclasi con il sistema del K+ e del riassorbimento del K+ e la diarrea, che raggiunge i suoi vertici, quale malattia, nel colera che, appunto, provoca una forte disidratazione. Infatti queste malattie si caratterizzano per una forte perdita di liquidi e diarrea.
L’incubazione è breve, da 6 a 48 ore dall’ingestione del cibo infetto con la comparsa di dolori crampiformi e diarree molto forti appunto legate all’AMPciclico, all’Adenilciclasi, al blocco dell’Adenilciclasi, e abbiamo una perdita di liquidi.
Il quadro clinico solitamente si caratterizza per febbre elevata e diarrea infiammatoria (acquosa-sanguinolenta), manifestazioni cliniche assenti in questa paziente.
Sono gravi nei bambini, nei lattanti e nelle persone anziane per le conseguenze legate alla severa disidratazione che tale processo infettivo comporta in seguito alle scariche diarroiche.
La guarigione spontanea in 4-5 giorni è in genere l’evenienza più frequente. La terapia sintomatica è favorevole in queste forme.
Se si esegue come test diagnostico la coprocoltura, questa sarà positiva fino a due settimane dopo l’inizio dell’infezione.