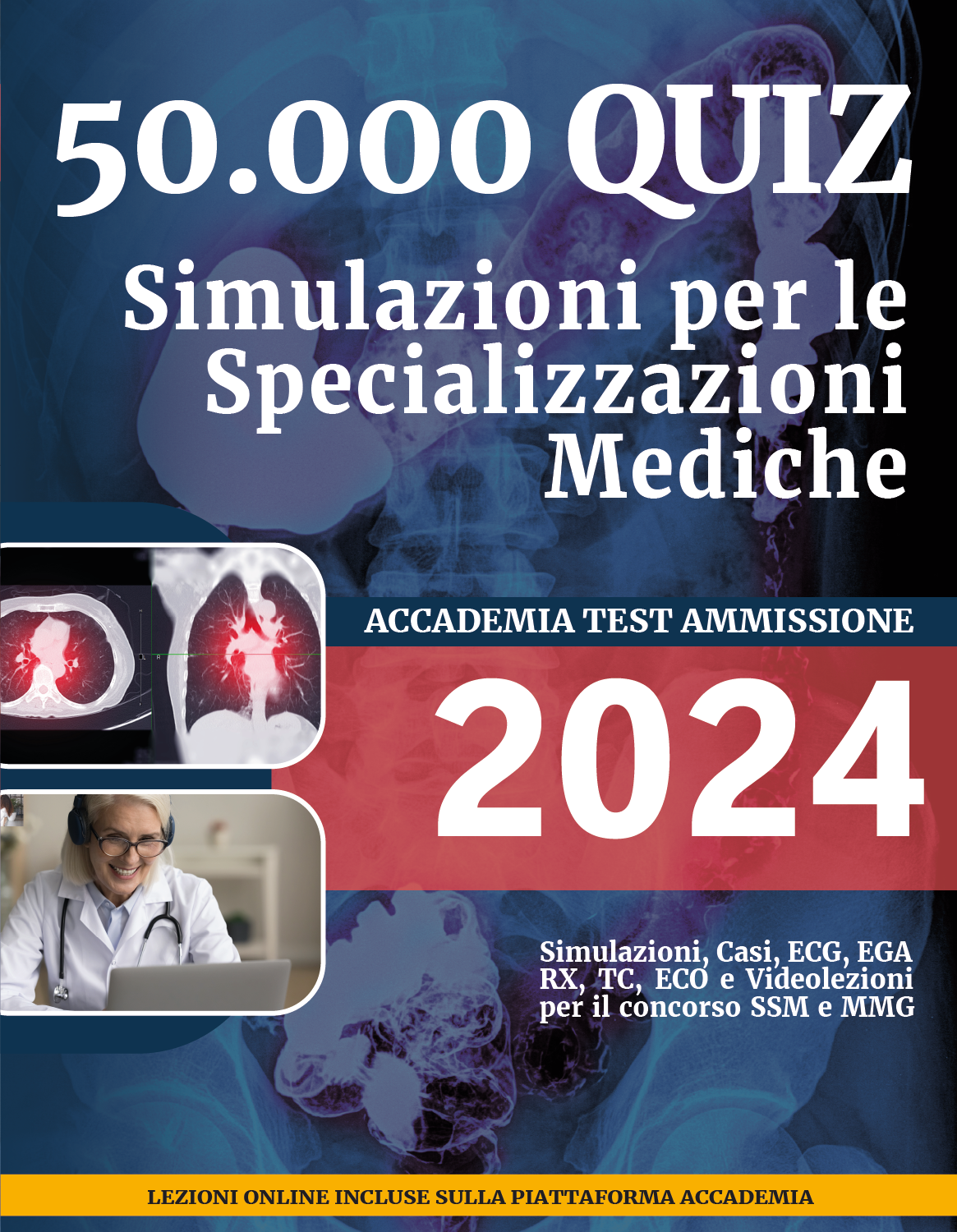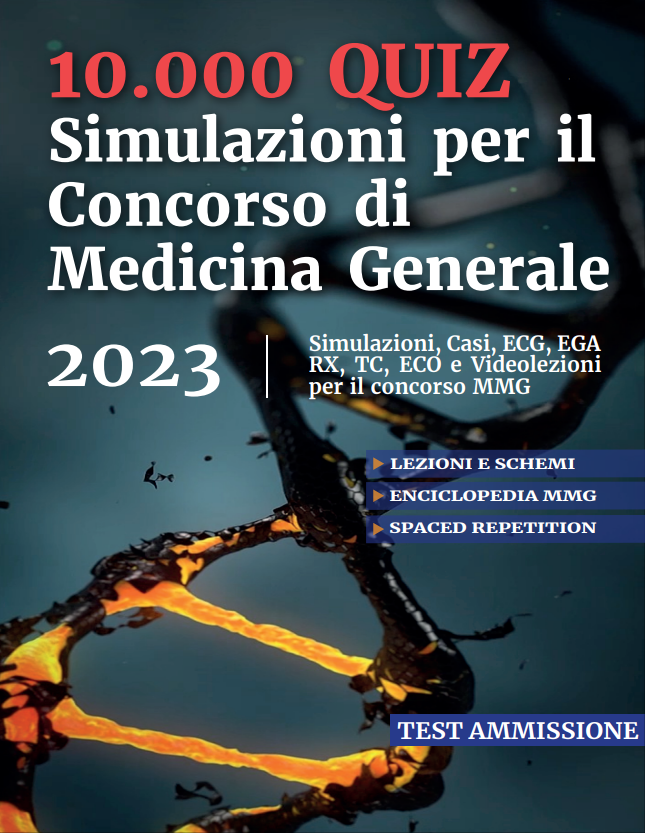La risposta corretta è la C.
La malattia di Osgood-Schlatter fa parte di un gruppo di patologie note come ostocondrosi. Si tratta di un processo degenerativo a carico dell’osso tibiale, in particolare della tuberosità tibiale. Si presenta tipicamente nell’età pre-adolescenziale, di solito tra i 10-15 anni e il suo decorso cessa intorno ai 18-20 anni con il termine della crescita e la calcificazione ossea.
E’ più frequente nei ragazzi e questo è da ricollegarsi alla sua patogenesi; infatti questa patologia è dovuta allo stress meccanico esercitato dalla tensione del tendine del muscolo quadricipite che va proprio ad inserirsi, una volta superata la rotula, e assumendo il nome di legamento patellare, a livello della tuberosità tibiale. In età pre-adolescenziale questa regione è ancora in fase di accrescimento, e la sollecitazione continua può provocare infiammazione e frammentazione ossea, oppure portare ad una crescita ossea anomala con alterazioni morfologiche (es. osso sporgente) Dato che si tratta di una condizione da ricondursi ad insulto meccanico cronico e ripetitivo, è questo il motivo per cui si presenta soprattutto negli individui impegnati in attività sportive.
Si presenta come una protuberanza unilaterale localizzata in prossimità del ginocchio, a livello della cresta tibiale, dolente soprattutto durante attività fisiche più o meno intense (che naturalmente vanno a sollecitare tale porzione) ed infiammata. Non sono presenti sintomi sistemici.
All’esame radiografico si potrà osservare un edema aspecifico dei tessuti molli e talvolta anche ossificazione frammentaria a livello del tubercolo tibiale.
Si tratta di una condizione generalmente benigna che tende ad auto risolversi e i cui segni tendono a scomparire con il passare degli anni.
La terapia è sintomatica; è consigliato il riposo assoluto, associato o meno all’impiego di un tutore; il continuo stress meccanico potrebbe portare al cronicizzarsi dei sintomi e alla necessità di intervento chirurgico. La somministrazione di antidolorifici potrebbe essere utile per lenire le algie.
La risposta A non è corretta.
L’artrite settica è una condizione infettiva che si sviluppa a carico di una o più articolazioni ed è causata dalla presenza di microrganismi nello spazio sinoviale.
I patogeni più frequentemente coinvolti sono i batteri; lo Staphilococcus Aureus è il germe più spesso isolato.
Può avvenire in conseguenza di un trauma diretto oppure per diffusione ematica di un processo infettivo localizzato in un altro distretto corporeo.
Le articolazioni più colpite sono quelle degli arti inferiori, il ginocchio in particolar modo; seguono la spalla, il polso, il gomito e la caviglia.
L’articolazione interessata si presenta arrossata, tumefatta, gonfia, dolente e dolorabile, presenta quindi tutti i classici segni dell’infiammazione. Sono associati sintomi sistemici come febbre alta e brividi.
La diagnosi viene fatta con l’esame obiettivo, con l’esame di un campione di liquido sinoviale, con gli esami ematochimici e radiologici.
Il trattamento prevede il drenaggio della raccolta infetta, la detersione e la disinfezione e naturalmente la terapia antibiotica.
La risposta B non è corretta.
La frattura traumatica della tibia è una lesione generalmente poco frequente poiché si verifica soprattutto in seguito ad impatti di una certa rilevanza oppure per una rotazione scorretta della caviglia oppure a causa di una caduta seguente ad un salto. Non raramente si verificano durante la pratica di attività sportive; quelle più a rischio sono quelli in cui si effettuano salti che si sviluppano in altezza oppure sport in cui si verificano spesso contatti fisici violenti come calcio, football americano, rugby.
La tibia è il secondo osso più lungo del corpo umano e la sua frattura, data la natura dell’impatto, spesso è associata a lesioni coinvolgenti altre sedi.
I traumi provocanti la frattura della tibia possono essere di entità più modesta ma provocare ugualmente delle lesioni quando si associano a patologie sottostanti determinanti una condizione di fragilità ossea come osteopenia o osteoporosi.
Solitamente la parte antero-inferiore, cioè la parte più distale, è più interessata da fratture rispetto alla porzione prossimale.
La frattura si manifesta generalmente con dolore alquanto intenso che può essere avvertito sia nella parte anteriore che in quella posteriore della gamba; può aggiungersi l’edema dei tessuti molli e talvolta anche un ematoma.
Nei casi in cui il soggetto non avverte dolore, può invece riferire formicolio o senso di intorpidimento dell’arto. Si può inoltre notare una deformità nel profilo osseo.
La radiografia permette di evidenziare la frattura e di definirne le caratteristiche.
La risposta D non è corretta.
Con “malattia di Legg-Calvè-Perthès” si intende la condizione di necrosi avascolare e asettica della testa del femore, mono o bilaterale, che si verifica nei bambini (generalmente tra i 2 e i 12 anni, con maggiore frequenza in quelli di sesso maschile).
Il bambino assume inizialmente una andatura claudicante per il dolore alle anche, alle cosce e alle ginocchia e una ridotta mobilità dell’anca. Si può osservare, con il passare del tempo, una crescente discrepanza nella crescita tra i due arti, con una visibile differenza di lunghezza.
Si tratta di una patologia ad andamento cronico ed invalidante; la fase attiva può infatti durare diversi anni e portare ad una necrosi totale o parziale della testa del femore. Gli esiti possono assumere uno spettro di gravità estremamente ampio.
Le cause non sono state identificate in maniera univoca; si ritiene che esistano delle forme familiari, associate a mutazioni del gene COL2A1, localizzato sul cromosoma 12, e delle forme multifattoriali, favorite ad esempio da disturbi della coagulazione, traumi, deficit di crescita, e altre condizioni comportanti una interruzione della vascolarizzazione.
La risposta E non è corretta.
La necrosi avascolare dell’anca o la necrosi asettica della testa del femore è una condizione che si verifica quando l’apporto ematico a questo distretto si interrompe.
Le cause possono essere molteplici: riconosciamo i traumi quali le fratture intracapsulari del collo del femore, lussazione dell’anca, interventi iatrogeni, eventi embolici, coagulopatie, patologie metaboliche, patologie da accumulo lisosomiale come la malattia di Fabry, malattie infettive, patologie reumatiche, gravidanza, farmaci (cortisone), assunzione cronica ed eccessiva di alcol, e altre cause idiopatiche.
All’esame radiografico la necrosi può non evidenziarsi subito poiché inizialmente l’ischemia riguarda la componente ossea cellulare e non quella minerale; i reperti possono essere visibili dopo 2 o 3 mesi. Estremamente più specifica è la risonanza magnetica che permette di individuare le lesioni ancor prima che siano visibili alla radiografia tradizionale.