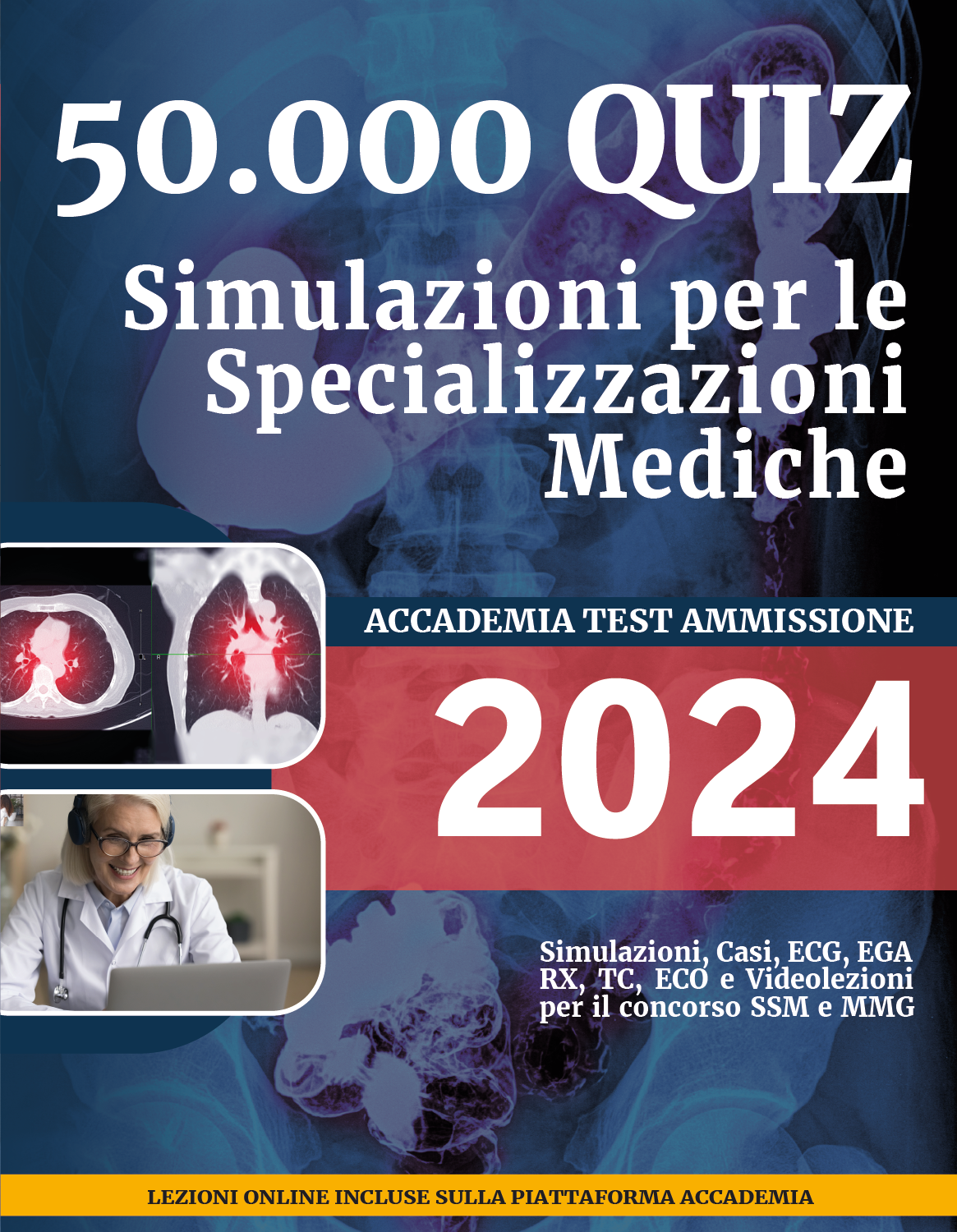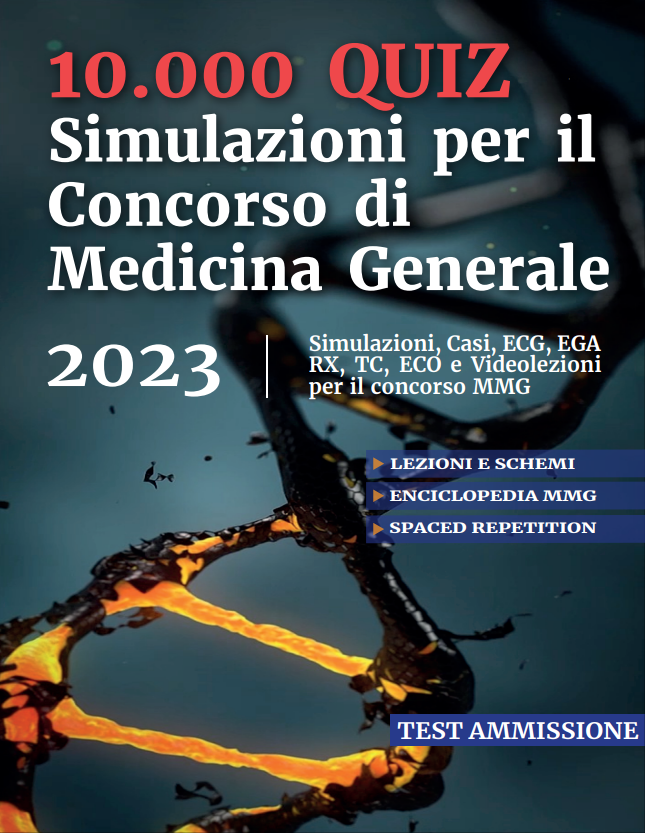La risposta corretta è la A.
Le cisti renali sono formazioni grossolanamente sferiche, a contenuto liquido, che si sviluppano nel contesto del parenchima renale. Possono far parte di malattie ereditarie, come nel caso della malattia del rene policistico in cui le cisti sono presenti dalla nascita, oppure essere acquisite, sviluppandosi cioè nel corso della vita. Gli studi autoptici hanno dimostrato che le cisti renali sono molto frequenti, presentandosi in più del 50% dei soggetti oltre i 50 anni di età.
Il paziente in questione mostra una cisti renale semplice (struttura regolare, uniloculata, senza setti interni, contenuto omogeneo, senza presa di contrasto): esse non richiedono ulteriori accertamenti diagnostici, a meno che non siano di enormi dimensioni (>9,9 cm) ed il paziente pertanto può essere rassicurato dato che questa ciste renale è sicuramente più piccola.
Le caratteristiche che suggeriscono una malignità includono: struttura irregolare o multiloculare con più setti, contenuto eterogeneo ed enhancement contrastografico alla TC, RM;
Le cisti sono definite semplici quando si sviluppano a partire dalla corticale del rene (cioè dalla parte più esterna), sono di forma sferica e ovale, hanno profili ben definiti, pareti sottili e contenuto liquido omogeneo di densità simile all’acqua. Possono essere di varie dimensioni, da pochi mm a oltre 15 cm, e circa un quarto di esse tende ad aumentare di dimensioni con il tempo, soprattutto nei soggetti giovani. Le cisti renali acquisite semplici sono raramente sintomatiche (Il più delle volte, le cisti non causano ipertensione, dolore al fianco, ematuria,o proteinuria ed un processo infettivo si verifica molto raramente), per questo motivo nella maggior parte dei casi vengono individuate casualmente durante esami radiologici, come ecografia e TC, eseguiti per altri motivi.
Occasionalmente possono diventare sintomatiche, provocando dolore al fianco, disturbi addominali o ematuria (sangue nelle urine). Questo può essere il risultato dell’aumento di dimensioni della cisti oppure dell’insorgenza di una complicazione. Le complicazioni sono rare (2-4%) e consistono in: emorragia, infezione o rottura della cisti. L’emorragia può essere determinata da un trauma, dal semplice aumento delle dimensioni oppure da un problema di coagulazione del soggetto. Le cisti emorragiche si risolvono autonomamente col tempo, ma possono residuare calcificazioni, setti, ispessimenti delle pareti che configurano le caratteristiche di una cisti complessa. Anche l’infezione di una cisti semplice può risolversi esitando nella modifica dei suoi aspetti morfologici.
La più nota classificazione delle cisti renali è stata proposta da Bosniak, ed è riconosciuta come utile strumento di diagnosi, valutazione e gestione delle lesioni cistiche del rene. La classificazione si basa su criteri morfologici individuabili alla TC con mezzo di contrasto.
Le risposte B ed E non sono corrette.
Il paziente in questione mostra una cisti renale semplice (struttura regolare, uniloculata, senza setti interni, contenuto omogeneo, senza presa di contrasto): esse non richiedono ulteriori accertamenti diagnostici, a meno che non siano di enormi dimensioni (>9,9 cm) ed il paziente pertanto può essere rassicurato dato che questa ciste renale è sicuramente più piccola.
La semplice cisti benigna non richiede l’esportazione dell’intero rene o l’escissione chirurgica della ciste.
La risposta C non è corretta.
Il paziente non mostra nessun dato clinico e anamnestico che giustificherebbe l’utilizzo di antibiotici: gastroenterite, faringite, infezione genito-urinaria, sepsi, shock settico e altre patologie che richiedono l’uso di antibiotici.
La risposta D non è corretta.
Lo stent ureterale è un sottile tubo flessibile di materiale plastico, che viene inserito nell’uretere per facilitare il deflusso dell’urina dal rene alla vescica. Le due estremità dello stent sono arrotolate a formare una specie di ricciolo, da cui il nome di stent a “doppio J”. Sebbene esistano differenti tipologie di stent ureterali, tutti hanno lo stesso scopo: garantire il drenaggio delle urine dal rene alla vescica (in caso ad esempio di: ostruzione urinaria dell’uretere o della pelvi renale. Alla valutazione radiologica ci aspetteremmo di riscontrare: idronefrosi o idrouretere). Questo paziente non ha sintomi di ostruzione urinaria o segni radiologici di ostruzione mostrati all’esame TC dell’addome.
Per inserire uno stent ureterale è necessaria una procedura endoscopica che, di solito, richiede l’anestesia generale o regionale. Attraverso un cistoscopio, strumento che permette di entrare nella vescica percorrendo l’uretra per via retrograda, lo stent viene fatto risalire nell’uretere con l’aiuto di un filo guida. La corretta posizione dell’estremo superiore dello stent viene verificata durante la procedura grazie alla radioscopia (raggi-x).