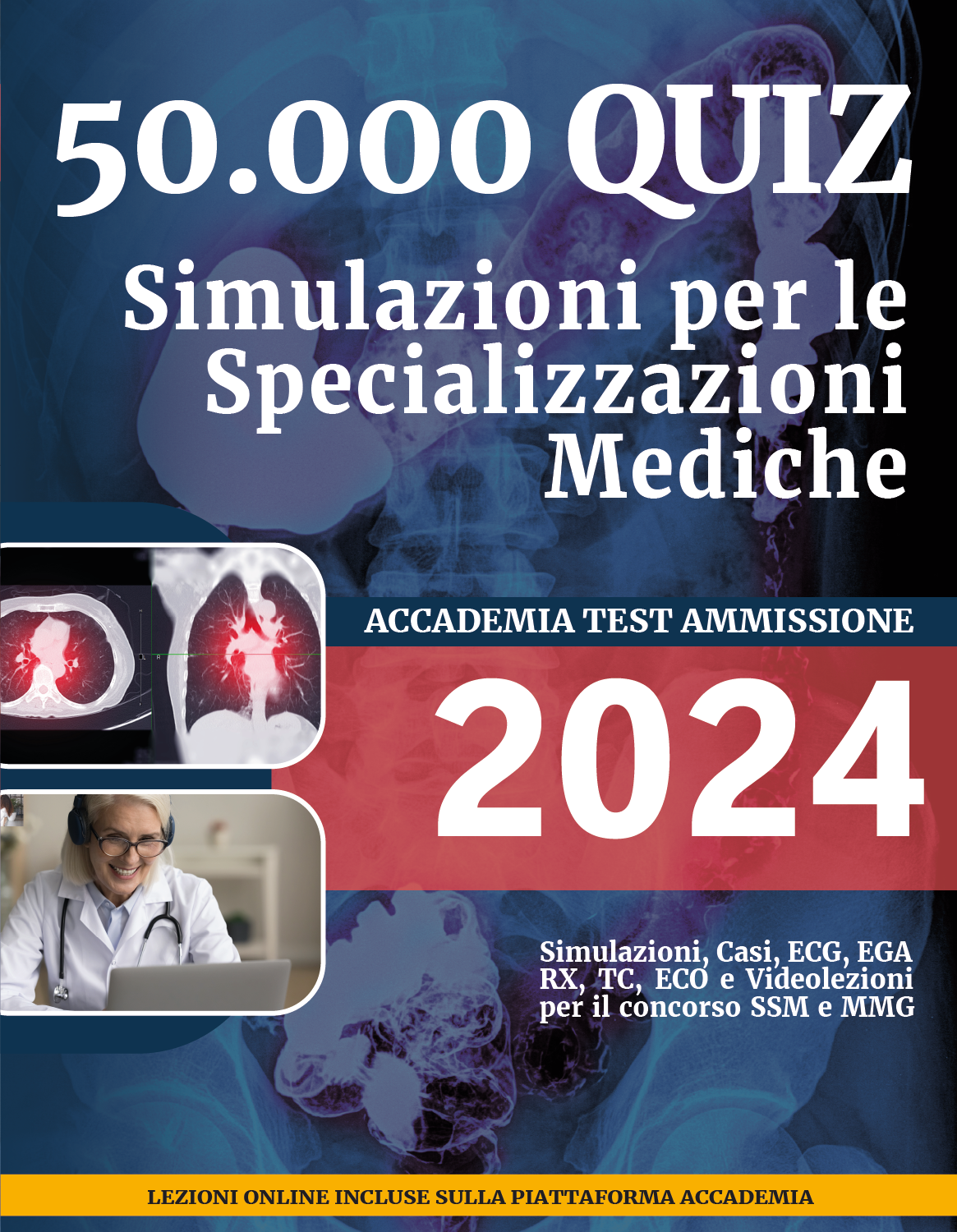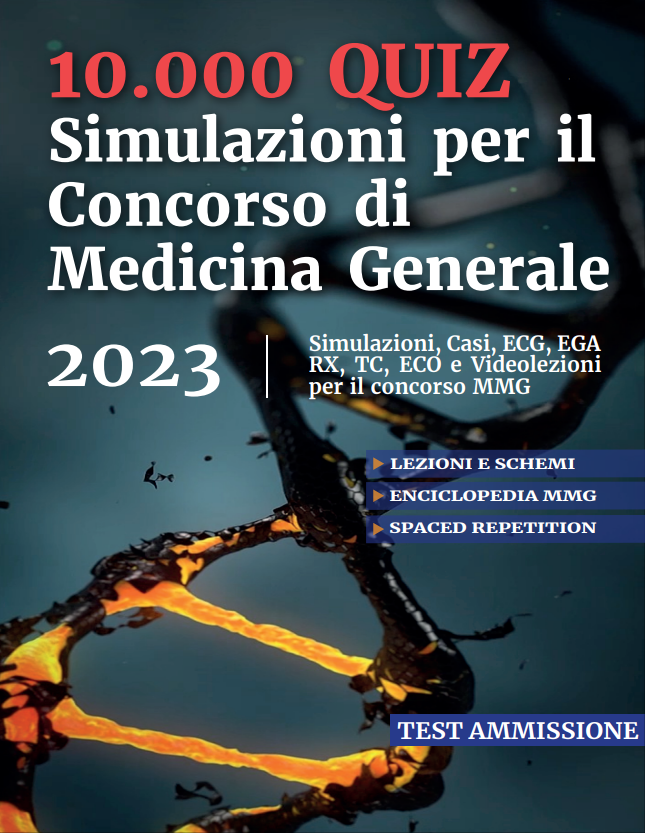La risposta corretta è la C.
Si definisce anemia megaloblastica un’anemia caratterizzata da eritroblasti anomali che sono detti megaloblasti in quanto caratterizzati da un volume corpuscolare medio (MCV) >100 ft. È determinata da un difetto nella sintesi di DNA conseguente a carenza di vitamina B12 e/o folati.
La sintesi di DNA richiede che ci sia a disposizione una sufficiente quantità di acido tetraidrofolato: esso, tuttavia, è presente in forma di N5-metil-tetraidrofolato il quale per trasformarsi in acido tetraidrofolato cede un gruppo metilico alla vitamina B12; in presenza di una ridotta quantità di vitamina B12 questa cessione del gruppo metile non sarà possibile, con conseguente difficoltà nella sintesi del DNA.
La vitamina B 12 si trova negli alimenti di origine animale, è resistente alla cottura, e si lega al fattore intrinseco, prodotto dalle cellule parietali del corpo e del fondo gastrico, che ne permette l’assorbimento a livello dell’ileo. Inoltre essa è implicata anche nel favorire l’ingresso dell’acido folico nelle cellule.
L’acido folico non si trova nei tessuti in questa forma ma è il capostipite di una serie di composti, tra cui il 5-metil-tetraidrofolato nel fegato, ottenuti da reazioni di riduzione.
Una carenza di vitamina B12 o di folati può determinarsi per insufficiente introduzione , per ridotto apporto con la dieta, aumentato fabbisogno per aumento della richiesta, malassorbimento o inadeguata utilizzazione.
Nel caso della vitamina B 12 la causa più frequente di carenza è il malassorbimento dovuto ad alterazioni nella secrezione del fattore intrinseco (nell’anemia perniciosa, o nella gastrectomia), a malattie croniche intestinali (ad esempio morbo celiaco) o ad alterazioni anatomiche dell’intestino (come nel caso di ileiti o resezioni ileari).
Nel caso dell’acido folico, invece, è frequente che vi siano situazioni di ridotto apporto, come può accadere negli anziani, così com’è frequente una condizione di malassorbimento dovuta a malattie croniche dell’intestino tenue, utilizzo di alcuni farmaci come gli anticonvulsivi o carenza di vitamina B12 . Nelle condizioni in cui vi è un aumento della sintesi del DNA, inoltre, potrebbe verificarsi una carenza di acido folico come nel caso di stati fisiologici, come la gravidanza, o patologici, come nelle neoplasie.
Dal punto di vista clinico le anemie megaloblastiche si presentano con sintomi aspecifici, comuni ad altre forme di anemia tra cui astenia ingravescente, sonnolenza, aumentata sensibilità al freddo accompagnati, in casi do deficit della vitamina B12, a parestesie a livello di mani e piedi, difficoltà nella deambulazione e raramente paresi spastica e neurite retrobulbare.
La diagnosi si avvale di un’adeguata anamnesi, clinica ed esame obiettivo ma soprattutto di esami strumentali tra cui l’esame emocromocitometrico che mette in evidenza una riduzione del contenuto di emoglobina, del numero dei globuli rossi, del valore dell’ematocrito ed un aumento del volume corpuscolare medio. Non si ha ipercromia, la concentrazione di emoglobina per ogni emazia è normale. Patognomonico è il risultato dello striscio di sangue periferico, che mostra la presenza di macrociti, anche se la diagnosi di certezza si ottiene solamente con la biopsia del midollo.
La risposta A non è corretta.
L’anemia presente nei pazienti con IRC è un’anemia iporigenerativa conseguente alla ridotta attività nella secrezione dell’eritropoietina a livello renale. L’anemia è normocitica, con eritrociti dismorfici detti echinociti, caratterizzati da irregolarità citoplasmatiche e riduzione dei reticolociti.
La risposta B non è corretta.
Le talassemie sono un gruppo di anemie ereditarie caratterizzate da una ridotta o abolita produzione di una o più catene peptidiche che costituiscono la porzione globinica dell’emoglobina.
Le beta-talassemie derivano da difetti nella produzione delle catene beta; i quadri clinici associati a questa condizione possono essere due, cioè:
Assenza completa delle catene beta;
Ridotta sintesi di catene beta.
Si parla di trait-talassemico nelle forme di talassemia beta minor, nella quale i soggetti sono portatori silenti, cioè eterozigoti, per la beta talassemia. In questi soggetti manca ogni manifestazione di malattia e l’esame emocormocitometrico mostra una poliglobulia associata ad anemia ipocromica e microcitica. Il riconoscimento di questi soggetti è importante al fine di un’adeguata profilassi della talassemia major ( malattia di Cooley).
La risposta D non è corretta.
L’anemia associata ad infiammazione cronica è una condizione clinica di frequente riscontro in pazienti portatori di neoplasie, infezioni croniche e malattie infiammatorie croniche. Si tratta di un’anemia ipoproliferativa normocromica e normocitica o microcitica, con riduzione dell’emoglobina e reticolociti normali o ridotti di poco. È caratteristico l’assetto marziale in cui vi è riduzione della sideremia, della transferrinemia e aumento della ferritinemia.
La risposta E non è corretta.
L’anemia sideropenica è una forma di anemia che si sviluppa quando la disponibilità di ferro nell’organismo è insufficiente per un’adeguata sintesi di emoglobina. Si tratta di un’anemia microcitica, ipocromica con riduzione dell’emoglobina, dell’ematocrito e del numero totale dei globuli rossi. L’eritropoiesi è anomala per cui nello striscio di sangue è possibile trovare delle alterazioni morfologiche delle emazie note come anisocitosi, cioè emazie di grandezza differente, e poichilocitosi, GR di forme bizzarre. Un parametro patognomonico è la sideremia, che raggiunge valori molto bassi insieme alla ferritinemia, mentre il valore della transferrina è aumentato.