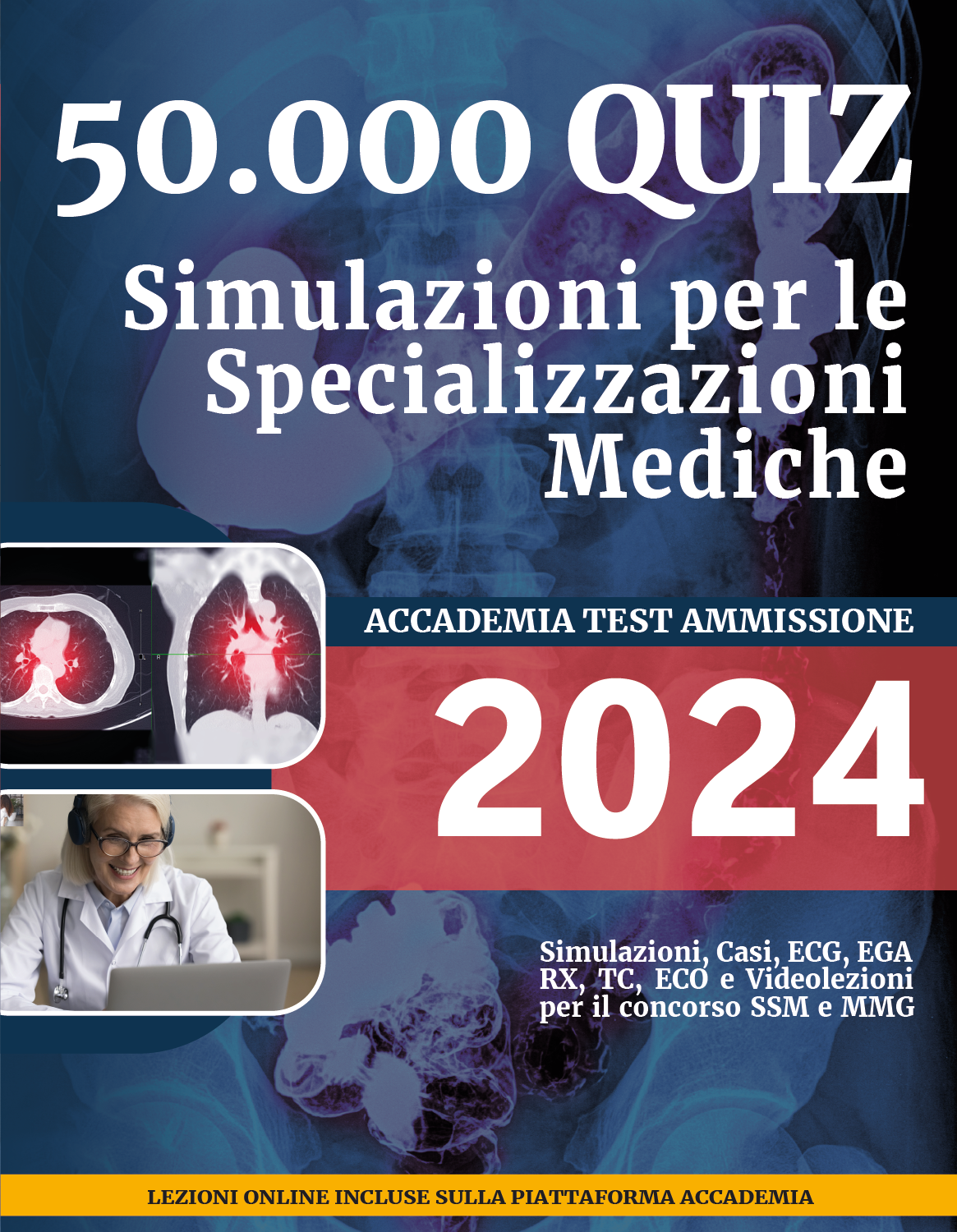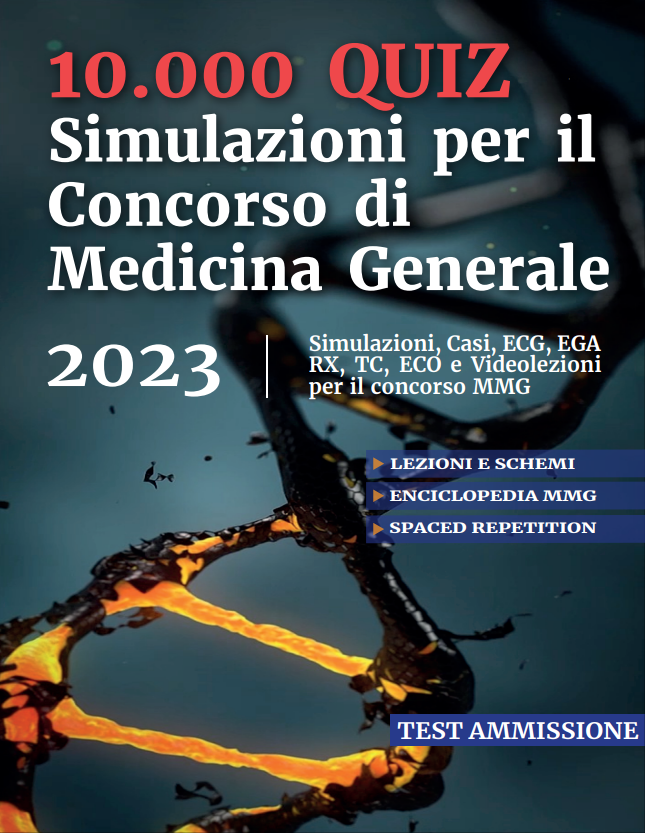La risposta corretta è la D.
Il dottor Bianchi comunicherà a Ferdinando che è affetto dalla Malattia di Lyme, una zoonosi che si acquisisce a causa del morso di zecca (è trasmessa principalmente da 4 specie di zecche Ixodes sp) e l’ agente eziologico alla base dell’ infezione è la spirocheta Borrelia burgdorferi.
L’ anamnesi positiva per un recente viaggio in campeggio è un ulteriore dato che avvalora tale ipotesi diagnostica. La malattia di Lyme è endemica nel nord-est degli USA e si manifesta con un eritema cronico migrante, come descritto in questo caso, ovvero una lesione cutanea a carattere papulomatoso, fortemente eritematosa, che poi gradualmente si estende a formare una lesione molto più estesa, con al centro una zona necrotica o maggiormente rossastra e con dei bordi finemente rilevati.
I sintomi iniziali comprendono: malessere generalizzato e rash cutaneo di carattere eritematoso migrante, che può essere seguito dopo alcune settimane o mesi da alterazioni articolari, neurologiche o cardiache.
La diagnosi è fondamentalmente clinica negli stadi precoci della malattia, ma i test sierologici possono essere di sostegno nella diagnosi delle eventuali complicanze reumatologiche, neurologiche e/o cardiache che si manifestano nelle fasi avanzate della malattia. La terapia generalmente prevede la somministrazione di antibiotici come doxiciclina o ceftriaxone, mentre nelle donne incinta si predilige l’ amoxicillina, un antibiotico appartenente alla classe dei β-lattamici, che è il trattamento di scelta nelle donne in gravidanza e in allattamento, nonché i bambini di età inferiore a 8 anni.
La risposta A è errata
La miocardite è una flogosi miocardica accompagnata da necrosi dei miociti che solo raramente comporta un’ eruzione cutanea localizzata. Spesso segue un’ infezione virale (Il virus della Coxsackie B rappresenta la causa più comune di miocardite, che può anche portare a cardiomiopatia dilatativa) e si presenta con un quadro clinico caratterizzato da coinvolgimento delle vie aeree superiori, febbre, dispnea e dolore toracico. Il trattamento è volto a ridurre le richieste energetiche del miocardio. L’ uso della terapia immunosopressiva e antinfiammatoria dipende dalla causa sottostante e rimane ancora controverso.
La risposta B è errata
La storia clinica di una recente escursione in una zona endemica per la patologia di Lyme è altamente suggestiva di una patologia causata da una puntura di zecca. La meningite rappresenta una condizione patologica caratterizzata da un’ infiammazione delle delle meningi, in particolare dell’ aracnoide e della pia madre, cioè le leptomeningi, provocate dalla localizzazione diretta di un agente infettivo. Raramente si riconosce un’ eziologia non infettiva riconducibile ad una irritazione meningea da farmaci o agenti chimici. Molto spesso l’ infezione non interessa solo le meningi ma anche il sottostante parenchima cerebrale: si parla in questo caso di meningoencefaliti. Le meningiti batteriche sono le più frequenti e le più gravi. Anche quelle virali sono molto frequenti, a differenza di quelle da micoplasma, rickettsie, clamidie, protozoi, elminti che sono meno frequenti. La diagnosi di meningite si fa con l’ esame del liquor. Basta un sospetto di meningite a rendere indicata la puntura lombare che è l’ unico accertamento che ci dice con esattezza se è una meningite e che eziologia ha.
Tuttavia è sempre un bene fare un’ attenta diagnosi differenziale ed escludere una condizione di meningite, perché a volte se causata dalla Neisseria Meningitidis, può determinare un’eruzione cutanea, benchè di tipo petecchiale, associata a febbre alta, mal di testa, nausea e/o vomito, torcicollo e fotofobia, tutti sintomi che il nostro paziente nega.
La risposta C è errata
Gli stafilococchi sono microrganismi Gram-positivi aerobi. Lo Staphylococcus aureus è il germe più patogeno; causa tipicamente infezioni cutanee e talvolta polmoniti, endocarditi e osteomieliti. Porta spesso alla formazione di ascessi.
Lo Staphylococcus aureus è la causa predominante di impetigine non-bollosa e di ogni impetigine bollosa (la formazione delle bolle è dovuta all’ azione della tossina esfoliativa prodotta dagli stafilococchi).
Lo S. aureo infine può sovrainfettare anche delle lesioni cutanee come le punture di zecche, provocando delle lesioni ulcerative su base eritematosa. Nulla a che vedere, insomma, con l’ eritema cronico migrante presentato da Ferdinando. Sebbene si stiano rapidamente sviluppando dei ceppi resistenti a questi antibiotici, il trattamento prevede generalmente penicillina o vancomicina.
La risposta E è errata
La febbre maculosa delle Montagne Rocciose è un’infezione batterica, dovuta al batterio Rickettsia rickettsii, che si trasmette all’uomo con il morso della zecca del legno o del cane, correlata ad una mortalità stimata fino al 40%. La sintomatologia comprende l’ improvvisa comparsa di iperpiressia seguita dalla comparsa si un esantema dell’ area articolare di polsi e caviglie che si estende a volto, tronco, ascelle, glutei e alle aree palmari e plantari di mani e piedi: l’ eruzione descritta dal nostro paziente è molto più indicativa di malattia di Lyme, in quanto il rash della febbre maculosa delle Montagne Rocciose è più diffusa e presenta localizzazione preferenziale differente.
Inoltre anche in questa patologia si presentano sintomi neurologici quali cefalea, insonnia fino al coma.
Il trattamento si basa su doxiciclina o tetraciclina.