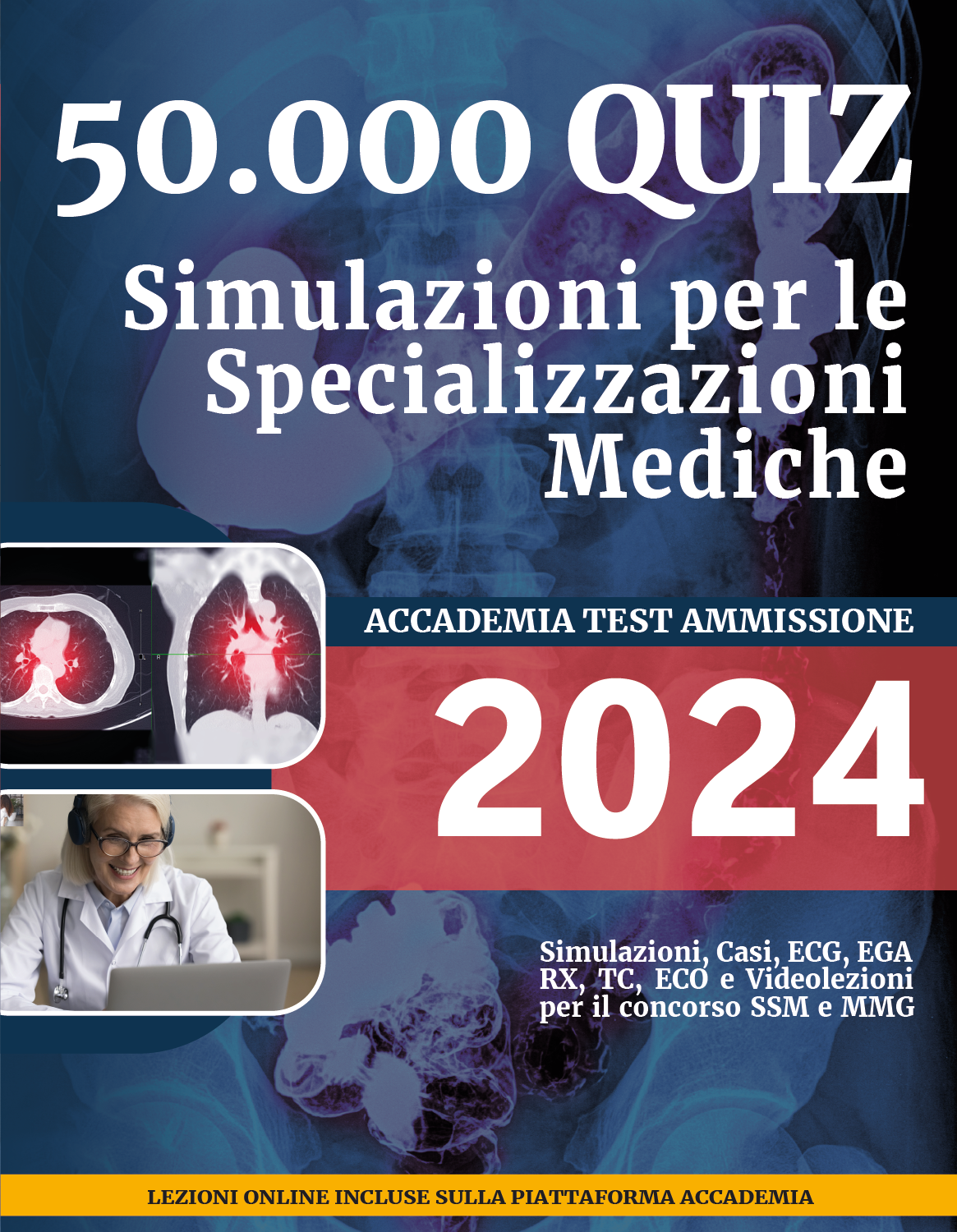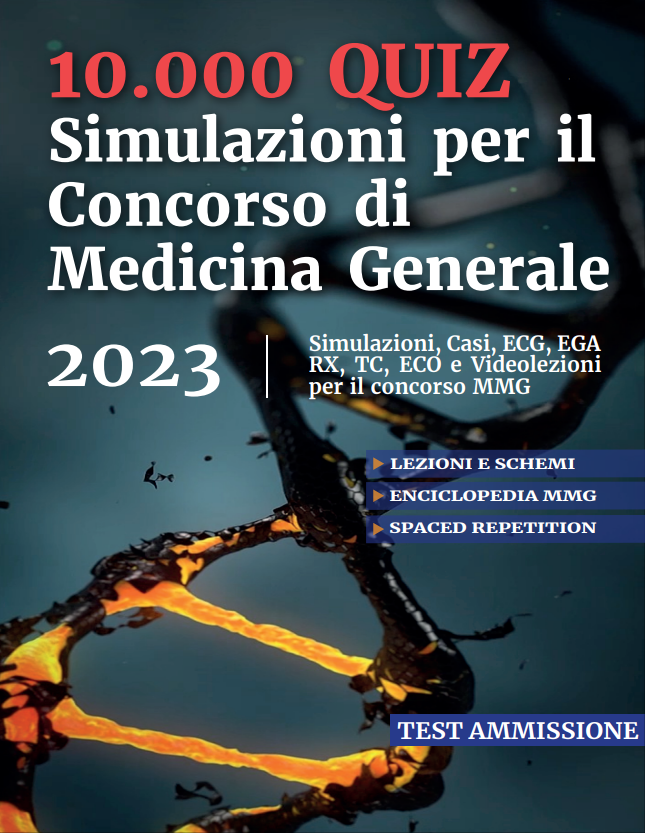La radiografia tradizionale utilizza una procedura di formazione dell’ immagine in cui, un fascio di raggi X attraversa alcuni tessuti subendo una diversa attenuazione a seconde della densità dei tessuti stessi, e questo fascio così modificato va a colpire un sistema di rilevazione costituito dalla pellicola radiografica. Questa ha il compito di tradurre le variazioni nella trasmissione dei raggi X in differenze di densità ottica, cioè in diversi livelli di grigio. I raggi X, generati dal tubo radiogeno, interagiscono con la materia verso cui vengono rivolti e in base alle caratteristiche di questa (densità , spessore, numero atomico) riusciranno ad attraversala in misura minore o maggiore.
La radiodensità della materia è il parametro alla base della formazione del radiogramma: l’ aria viene completamente attraversata ed apparirà iperdiafana (nera) mentre l’ osso non si lascerà attraversare ed apparirà fortemente radiopaco (bianco).
L’ esame radiografico del torace, nella sua semplicità di esecuzione, rapidità e bassa dose di radiazioni assorbite dal paziente, mantiene un ruolo fondamentale nella diagnostica delle patologie toraco-polmonari. Nella maggior parte dei casi, rappresenta l’ esame di prima scelta.
Le due proiezioni più frequentemente utilizzate sono quella postero-anteriore (frontale) e, a meno che non vi siano delle condizioni che ne limitino l’ esecuzione (es. decubito obbligato) , la latero-laterale. Il radiogramma da noi esaminato è stato eseguito in proiezione P-A.
L’ analisi delle caratteristiche del parenchima polmonare e dei profili pleurici sono fondamentali nella fase di valutazione dell’ esame radiografico.
Potremmo quindi porre la diagnosi di versamento pleurico sinistro (risposta esatta D, risposta B errata), in relazione anche alla sintomatologia del paziente: ciò che si evidenzia in questo radiogramma è la presenza di una obliterazione del seno costofrenico di sinistra, che risulta essere ipodiafano rispetto al parenchima polmonare, che tende a mascherare il profilo emi-diaframmatico omolaterale, obliterare il seno costo-frenico laterale complementare e sfumare la marginale cardiaca di pari livello (segno della silhouette).
Essendo stata eseguita la radiografia, verosimilmente, in ortostatismo, la forza di gravità e la pressione negativa intrapleurica costringono il liquido a disporsi nelle zone più declivi. Generalmente la presenza di versamento viene rilevata all’ Rx tradizionale quando raggiunge la quantità di circa 250 ml. Inizialmente si dispone lungo il seno costofrenico obliterandolo, poi, con l’ aumentare della quantità , tende a raccogliersi in posizione più declive e disporsi formando quello che è il cosiddetto menisco pleurico, una distribuzione del liquido con concavità superiore e margine laterale più alto rispetto al mediale; quando è particolarmente abbondante il versamento, tende a determinare un opacamento completo dell’ intero ambito polmonare.
Il focolaio broncopneumonico si presenta radiograficamente, nella maggior parte dei casi, con delle aree di radiopacità , di morfologia irregolare, confluenti, e quasi sempre ad estensione lobare o sublobare, spesso associate a contestuale presenza del broncogramma aereo (qui non presente, risposta A errata), che quindi esclude l’ ipotesi di atelettasia.
Nelle polmoniti di origine virale invece, possiamo avere una interstiziopatia, quindi un ispessimento del disegno polmonare interstiziale che talvolta evolve verso una polmonite interstizio-alveolare con evidenza di aree di riempimento alveolare (la polmonite alveolare è tipicamente di origine batterica) in cui si ha il passaggio di essudato a livello alveolare (essendo l’ alveolo non visualizzabile mediante radiografia, il primo elemento anatomico evidenziabile per la sua opacità , dovuta alla sostituzione dell’ aria con altro materiale, è l’ acino) (risposta A errata).
Lo pneumotorace, cioè la presenza di aria nella cavità nella cavità pleurica, si evidenzia sotto forma di una falda iperdiafana, nettamente separata dal parenchima polmonare da una linea netta, con evidenza della marginale pleurica e scomparsa del disegno polmonare (risposta C errata).