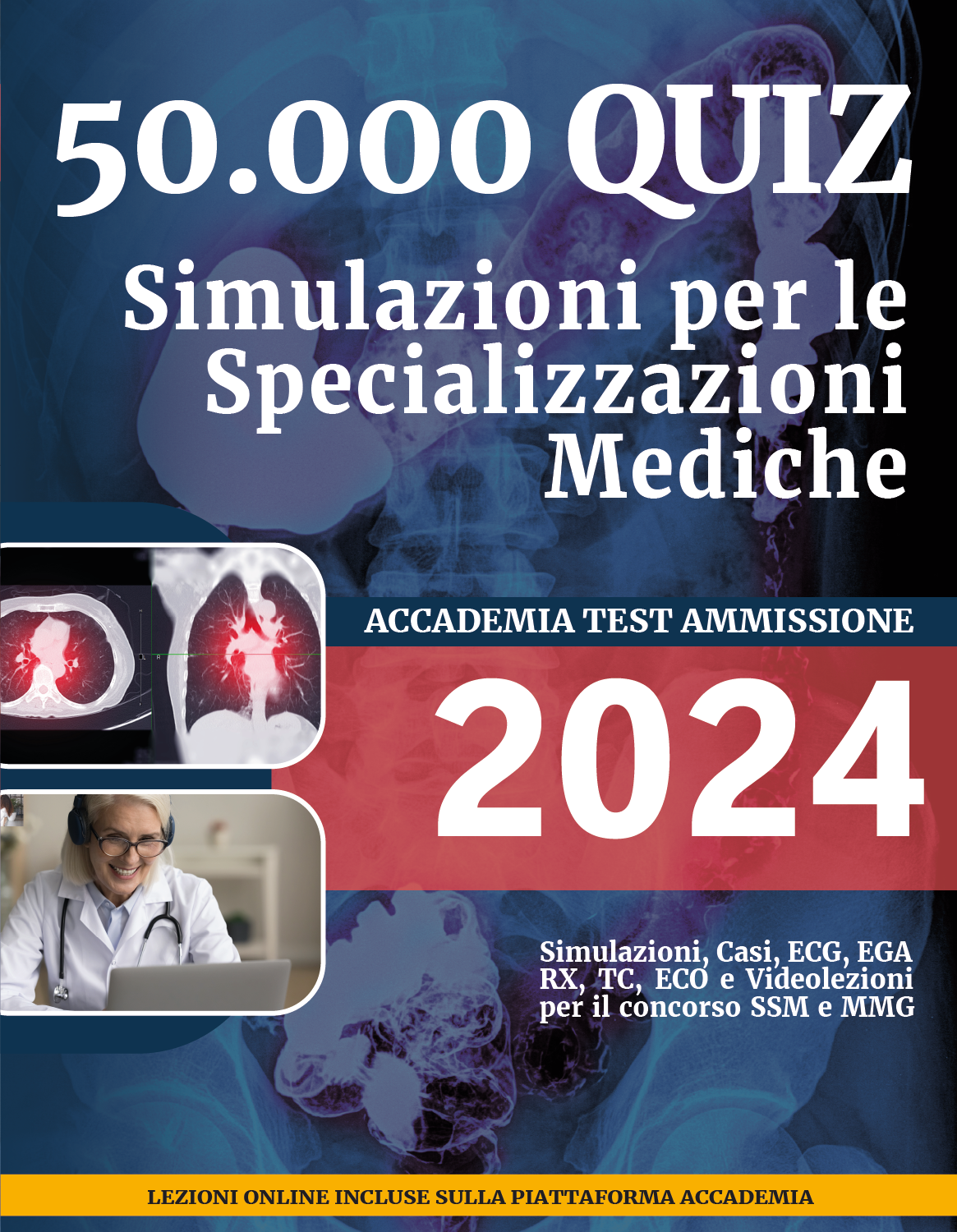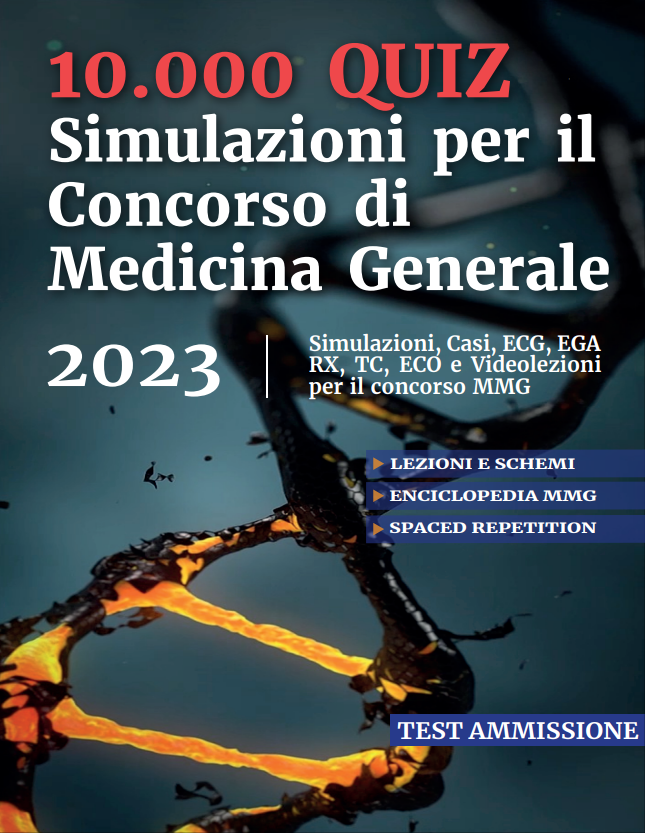La risposta corretta è la B.
La radiografia tradizionale utilizza una procedura di formazione dell’ immagine in cui, un fascio di raggi X attraversa alcuni tessuti subendo una diversa attenuazione a seconde della densità dei tessuti stessi, e questo fascio così modificato va a colpire un sistema di rilevazione costituito dalla pellicola radiografica. Questa ha il compito di tradurre le variazioni nella trasmissione dei raggi X in differenze di densità ottica, cioè in diversi livelli di grigio. I raggi X, generati dal tubo radiogeno, interagiscono con la materia verso cui vengono rivolti e in base alle caratteristiche di questa (densità , spessore, numero atomico) riusciranno ad attraversala in misura minore o maggiore.
La radiodensità della materia è il parametro alla base della formazione del radiogramma: l’ aria viene completamente attraversata ed apparirà iperdiafana (nera) mentre l’ osso non si lascerà attraversare ed apparirà fortemente radiopaco (bianco).
L’ esame radiografico del torace, nella sua semplicità di esecuzione, rapidità e bassa dose di radiazioni assorbite dal paziente, mantiene un ruolo fondamentale nella diagnostica delle patologie toraco-polmonari. Nella maggior parte dei casi, rappresenta l’ esame di prima scelta.
Le due proiezioni più frequentemente utilizzate sono quella postero-anteriore (frontale) e, a meno che non vi siano delle condizioni che ne limitino l’ esecuzione (es. decubito obbligato) , la latero-laterale. Il radiogramma da noi esaminato è stato eseguito in proiezione P-A.
L’ analisi delle caratteristiche del parenchima polmonare e dei profili pleurici sono fondamentali nella fase di valutazione dell’ esame radiografico.
Potremmo quindi porre la diagnosi di versamento pleurico destro, in relazione anche alla sintomatologia del paziente: ciò che si evidenzia in questo radiogramma è la presenza di una obliterazione del seno costofrenico di destra, che risulta essere ipodiafano rispetto al parenchima polmonare, che tende a mascherare il profilo emi-diaframmatico omolaterale, obliterare il seno costo-frenico laterale complementare e sfumare la marginale cardiaca di pari livello (segno della silhouette).
Essendo stata eseguita la radiografia, verosimilmente, in ortostatismo, la forza di gravità e la pressione negativa intrapleurica costringono il liquido a disporsi nelle zone più declivi. Generalmente la presenza di versamento viene rilevata all’ Rx tradizionale quando raggiunge la quantità di circa 250 ml. Inizialmente si dispone lungo il seno costofrenico obliterandolo, poi, con l’ aumentare della quantità , tende a raccogliersi in posizione più declive e disporsi formando quello che è il cosiddetto menisco pleurico, una distribuzione del liquido con concavità superiore e margine laterale più alto rispetto al mediale; quando è particolarmente abbondante il versamento, tende a determinare un opacamento completo dell’ intero ambito polmonare.
Se si vuole indagare ancora più in fondo alla situazione patologica presentata dal paziente, visto che il versamento pleurico può essere consensuale ad un processo flogistico o ad una eteroplasia polmonare, è necessario sottoporre il paziente ad una TAC con e senza mdc.
La Tc (tomografia computerizzata) è tipo di esame radiodiagnostico, che utilizza i raggi X, grazie al quale è possibile riprodurre immagini di sezioni o strati corporei, ultrasottili e dettagliati, in un tempo estremamente breve. Normalmente viene considerato un esame di secondo livello, utile a dirimere dubbi diagnostici di particolare rilevanza clinica.
Le immagini basali elaborate dallo studio Tc, vengono riprodotte su una scala di grigi, la cui intensità varia in base alla radiodensità (scala di Hounsfield) degli organi esplorati. Nella parte più bassa della scala troviamo la materia con maggiore trasparenza (l’ aria, -1000 Unita Hounsfield, colore nero), mentre nella parte più alta della scala troviamo la radiopacità più assoluta (osso, +1000 HU, colore nero). A 0 HU corrisponde la densità dell’ acqua.
Il mezzo di contrasto che si usa in TC è un mezzo di contrasto idrosolubile a concentrazione elevata (370 mgI/ml), preferibilmente non iodato ed è usato per una migliore definizione delle strutture parenchimali e caratterizzazione dei processi patologici, necessaria per un’ adeguata diagnosi differenziale.