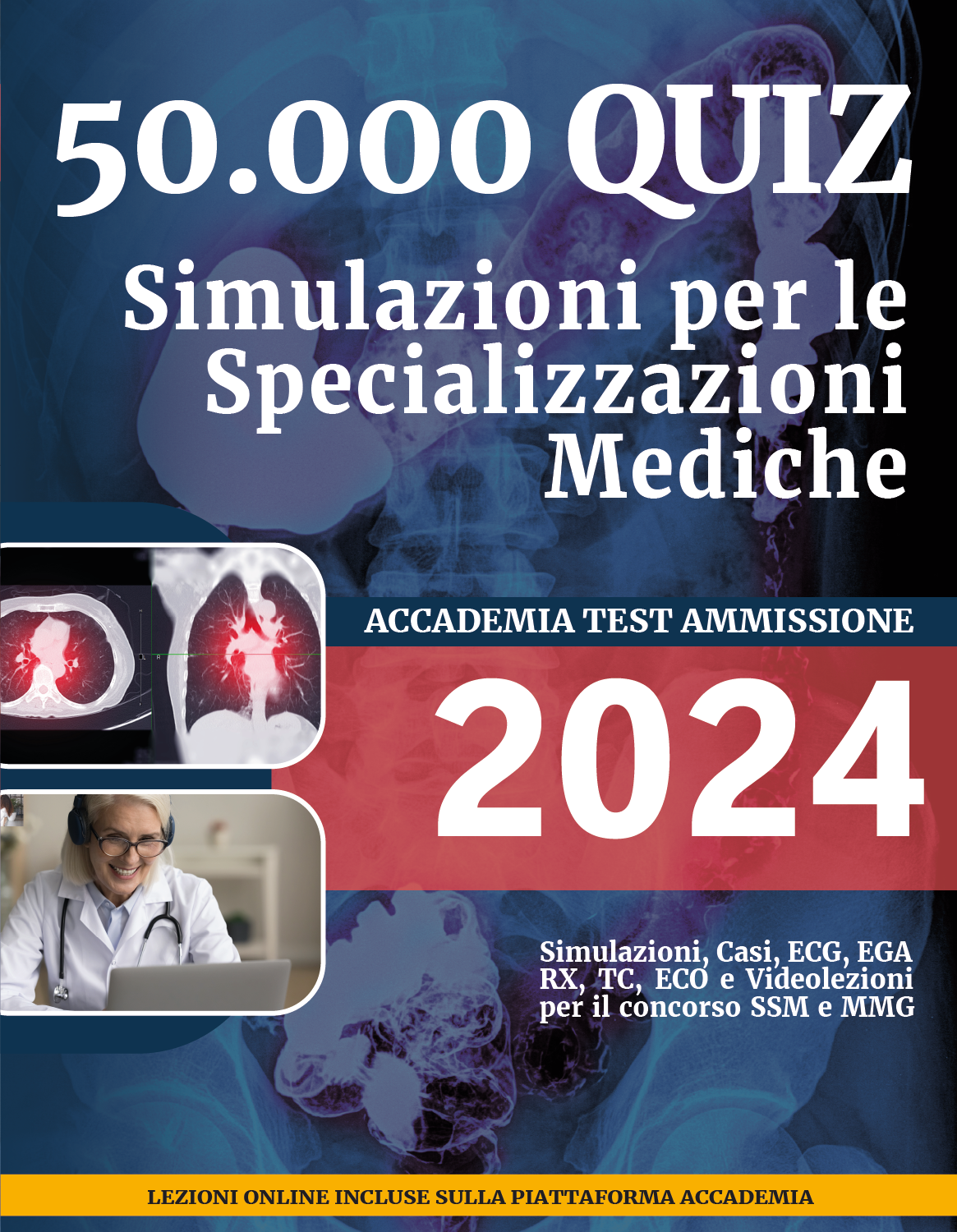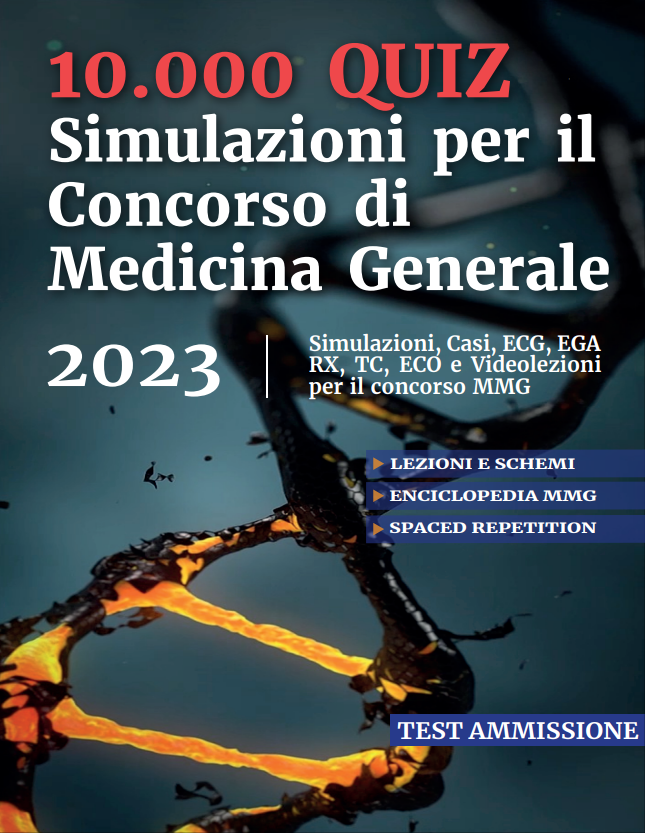La risposta esatta è la D.
Le prove di funzionalità respiratoria sono dei test che permettono di valutare l’adeguatezza della ventilazione e degli scambi gassosi. Nel primo caso avremo le misure dei volumi polmonari e dei flussi respiratori oppure i test di funzionalità dei muscoli respiratori. Nel secondo caso avremo il test di diffusione del monossido di carbonio e l’emogas analisi arteriosa più la saturimetria.
Il test più frequentemente utilizzato per la misura dei volumi statici e dinamici è la spirometria che, con l’applicazione del principio di Venturi, misura la quantità di aria inspirata ed espirata.
I volumi polmonari vengono espressi in litri, a pressione ambientale satura di vapore acqueo a 37 °C. Distinguiamo i volumi polmonari statici (Vt o volume corrente; VRI o volume di riserva inspiratoria; VRE o volume di riserva espiratoria; VR o volume residuo) e dinamici (VEMS o volume espiratorio massimo al secondo o FEV1; CVF o capacità vitale forzata; MVV o massima ventilazione volontaria).
Le capacità polmonari includono CV o capacità vitale, CI o capacità inspiratoria, CFR o capacità funzionale residua e CPT o capacità polmonare totale. Andiamo ad analizzare i risultati del nostro esame spirografico partendo da alcuni presupposti (non tutti i parametri elencati di seguito sono presenti nel nostro esame ma li citiamo per completezza): la FVC indica il volume totale di aria che viene espulsa in una espirazione forzata, partendo da una inspirazione massimale; la FEV1 è il volume di aria espirata nel 1 ° secondo di una espirazione forzata, partendo da una piena inspirazione; il MEF esprime la velocità massima che viene data all’aria durante l’esecuzione di una espirazione forzata iniziata dopo una inspirazione completa (convenzionalmente si valutano i massimi flussi al 25%, al 50% e al 75% della CVF); il rapporto FEV1/FVC (FEV1% o indice di Tiffenau) è la percentuale di CV espirata nel primo secondo; il FEF 25-75% è il flusso medio di aria espirata durante una espirazione forzata (viene solitamente misurato dal punto in cui il 25% sino al 75% della CVF è stato espirato).
Non tutti questi parametri sono espressi nel nostro esame, tuttavia, dai parametri a nostra disposizione, cioè una VEMS (o FEV1) bassa e un basso rapporto FEV1/CVF sono tipici dei pattern ostruttivi intrapolmonari come nel caso di asma bronchiale, BPCO e nelle bronchiectasie. La spirometria del nostro paziente è appunto riconducibile ad un pattern di tipo ostruttivo, motivo per cui la risposta corretta è la risposta alla lettera D.
La risposta A è errata.
Il morbo di Cushing o sindrome di Cushing è una condizione patologica conseguente ad una iperfunzione della corteccia surrenalica. Questa iperfunzione può essere ACTH-dipendente, quando dovuta ad una ipersecrezione di ACTH da parte della ipofisi, o da parte di un tumore non ipofisario secernente ACTH (es. carcinoide o tumore a piccole cellule del polmone: sindromi paraneoplastiche) oppure per somministrazione esogena di ACTH; altrimenti può essere una iperfunzione surrenalica ACTH- indipendente, riconducibile alla presenza di formazioni neoplastiche surrenaliche, o alla somministrazione esogena di steroidi.
Per essere più precisi, si parla di morbo di Cushing quando l’iperfunzione surrenalica è dovuta ad un eccesso di ACTH ipofisario e si parla di sindrome di Cushing quando l’eccesso di cortisolo è riconducibile ad altre cause.
I segni e i sintomi sono sistemici e quelli più frequenti comprendono: aumento del tessuto adiposo e aumento del peso, comparsa di strie rubre sulla pelle (soprattutto a livello dell’addome), facies lunare, irsutismo, alterazioni mestruali, astenia, debolezza, perdita di massa magra, osteoporosi, iperglicemia e possibile sviluppo di diabete, ipertensione arteriosa e altri.
Nonostante sia una condizione che presenta ripercussioni sistemiche e multiorganiche, non vi sono conseguenze dirette, sul parenchima polmonare o sulle strutture dell’apparato respiratorio, tali da poter essere sospettate mediante esame spirometrico. Per questo motivo, la risposta A risulta errata.
La risposta B è errata.
I pattern di tipo restrittivo, tipici di patologie della gabbia toracica, patologie neuromuscolari, fibrosi polmonare, lesioni occupanti spazio o compressioni ab estrinseco come nel caso di obesità o gravidanza, malattie pleuriche, invece sono solitamente caratterizzati da FEV1 bassa, CVF bassa e rapporto VEMS/CVF normale o superiore al normale.
Dati i valori del nostro esame, la risposta alla lettera B è errata.
La risposta C è errata.
La pericardite costrittiva configura un processo infiammatorio cronico coinvolgente il pericardio. Quando interessato da patologie a carattere infiammatorio , questa membrana sierosa può subire appunto una progressiva trasformazione in tessuto fibroso, cicatriziale. Questa minore elasticità del tessuto pericardico ne provoca rigidità e ridotta capacità di espansione delle camere cardiache.
I sintomi sono dovuti alla conseguente insufficienza cardiaca.
La spirometria non esplora la funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio, motivo per cui, da tale esame non possiamo supporre la diagnosi di pericardite costrittiva.