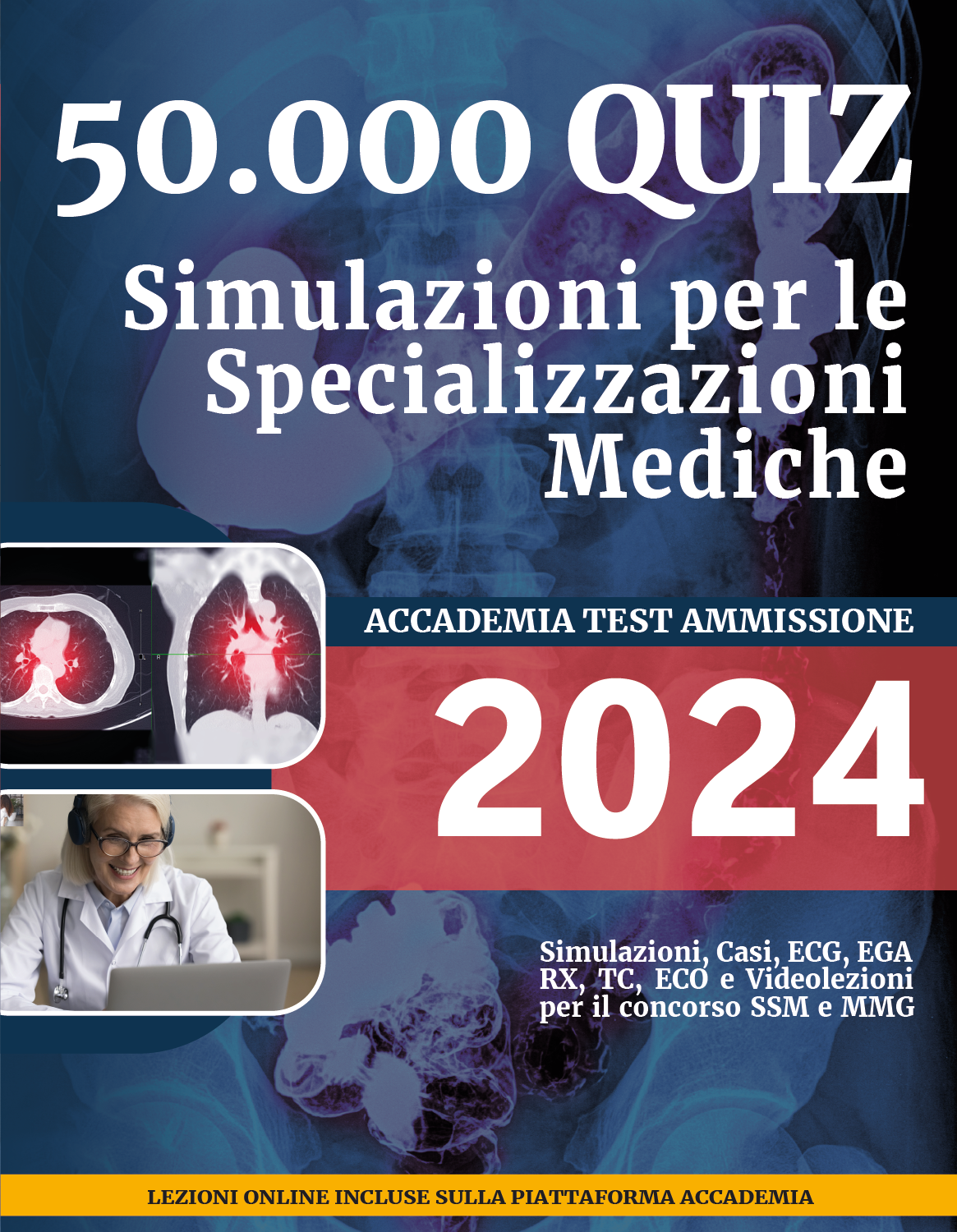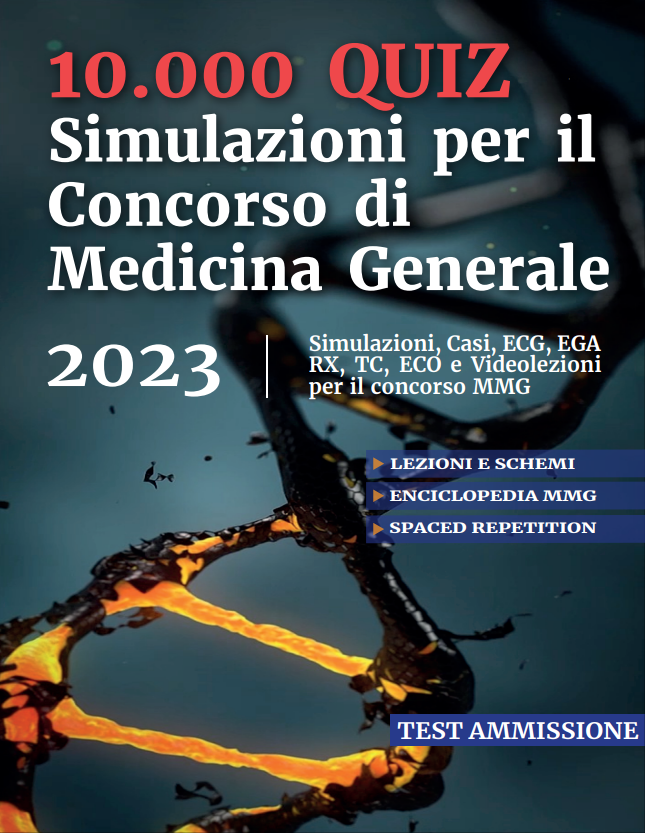La risposta corretta è la E.
Il pemfigo volgare è un disordine raro. Dal punto di vista eziologico, ritroviamo autoanticorpi IgG diretti contro le “ Ca-dependent cadherins desmoglein 1” e “ desmoglein 3” . Si ha dunque, una compromissione dell’ adesione cellula-cellula e una compromissione della segnalazione tra le cellule epidermiche; questo esita in l’acantolisi (perdita di adesione intracellulare).
In particolare, questa malattia può colpire qualsiasi area di epitelio squamoso stratificato (compreso le superfici mucose).
Dal punto di vista clinico, possiamo ritrovare bolle flaccide, che causano anche dolore cutaneo e erosioni orali e di altre mucose. Queste bolle si rompono e lasciano un’ area caratterizzata da disepitelizzazione e formazione di una crosta. È possibile, una infezione di queste lesioni.
Circa il 50% dei pazienti mostra solo lesioni orali (queste bolle tendono a rompersi, e rimangono sotto forma di lesioni croniche e dolorose) e questa è una caratteristica peculiare di tale quadro clinico.
Dal punto di vista di un rilievo semiologico caratteristico abbiamo il segno di Nikolsky positivo (separazione agevole degli strati superficiali cutanei dallo strato basale con successiva formazione di una bolla che si manifesta successivamente ad uno sfregamento cutaneo od ad un processo traumatico).
Gli anticorpi anti-desmogleine sono l’ elemento diagnostico più rilevante del pemfigo volgare.
La risposta A non è corretta.
La sindrome della cute ustionata da stafilococco, è una patologia molto particolare caratterizzata da una epidermolisi acuta, indotta da una tossina stafilococcica.
Dal punto di vista epidemiologico, questa patologia colpisce i bambini con meno di 6 anni.
Dal punto di vista clinico, ritroviamo bolle diffuse con disepitelizzazione che interessano pressoché tutta la superficie cutanea, reperto non descritto nel nostro caso.
La risposta B non è corretta.
Il mollusco contagioso, infezione deteminata dal poxvirus, si caratterizza clinicamente per la comparsa di gruppi di papule ombelicate centralmente non pruriginose ad aspetto perlaceo, a superficie liscia, rosata e con un diametro solitamente compreso tra 2 e 5 mm (pertanto non si presenta con bolle o erosioni come nel caso presentato).
La trasmissione avviene: per contatto diretto, per auto-inoculazione, indumenti o biancheria contaminate.
I pazienti in stato di immunodepressione sono a rischio di sviluppare un’infezione disseminata.
La risposta C non è corretta.
La psoriasi è una patologia infiammatoria che nella maggior parte dei casi si manifesta con papule e placche di color salmone ben circoscritte, eritematose e ricoperte da squame argentee mm (le lesioni patognomoniche della psoriasi non includono nè bolle, nè erosioni, come nel caso presentato).
Colpisce circa l’1-5% della popolazione mondiale. Inoltre colpisce di più le persone con una carnagione chiara, le persone con una carnagione più scura o i neri sono meno a rischio.
L’eziologia è multifattoriale e include la predisposizione genetica.
Solitamente, per quanto riguarda i sintomi essi sono minimi. Tuttavia, in casi gravi vi può essere prurito.
Una manifestazione particolare della psoriasi è l’ artrite psoriasica.
Il trattamento può comprendere l’utilizzo di emollienti, farmaci topici, fototerapia e, nelle forme gravi, di farmaci sistemici.
La risposta D non è corretta.
Il pemfigoide bolloso è una dermatosi bollosa cronica autoimmune, determinata dalla produzione di autoanticorpi in grado di attaccare alcune strutture degli emidesmosomi che consentono l’ adesione dello strato basale alla membrana basale.
L’ eziologia non è nota, è più frequente in soggetti di età <65 anni con familiarità per la stessa patologia, con anamnesi positiva per altre patologie autoimmuni o per altre patologie cutanee (come la psoriasi) o sistemiche (come il diabete mellito) e può scatenarsi in soggetti predisposti esposti a fattori esogeni come raggi UV e X, ustioni, alcuni farmaci. L’ incidenza aumenta tra gli individui affetti da neoplasie maligne o disordini neurologici.
È prodromica la comparsa di chiazze pruriginose orticariodi o eczematose; successivamente si assiste alla formazione di lesioni bollose a livello cutaneo del diametro medio di 2-3 cm, dalla superficie tesa e di consistenza rigida che se perforate emanano fluido sieroso; raramente interessano la mucosa. Compaiono in seguito all’ attivazione del complemento e il rilascio di mediatori della flogosi; il processo infiammatorio che ne deriva porta alla formazione delle bolle: tali bolle possono insorgere su cute normale o su zone cutanee eritematose soprattutto a livello delle zone flessorie e del tronco. Il pemfigoide bolloso pertanto è caratterizzato da bolle tese che non si rompono velocemente come quelle del pemfigo volgare.
Da un punto di vista diagnostico la prima diagnosi è clinica con segno di Nikolsky negativo, supportata laboratoristicamente da lucocitosi ed eosinofilia. La diagnosi di certezza la si ottiene tramite biopsia cutanea e l’ immunofluorescenza che evidenzia IgG e frazioni C3 del complemento disposte in modo lineare a livello della membrana basale.
Il trattamento di prima scelta, soprattutto nelle fasi iniziali, per il pemfigoide bolloso viene effettuato con glucocorticoidi ad altissima potenza per uso topico (es. clobetasolo), efficaci anche per una malattia molto estesa associati spesso a glucocorticoidi sistemici; nelle fasi successive, la maggioranza dei pazienti dovrà seguire a lungo termine una terapia di mantenimento, ove si potranno utilizzare immunosoppressori.