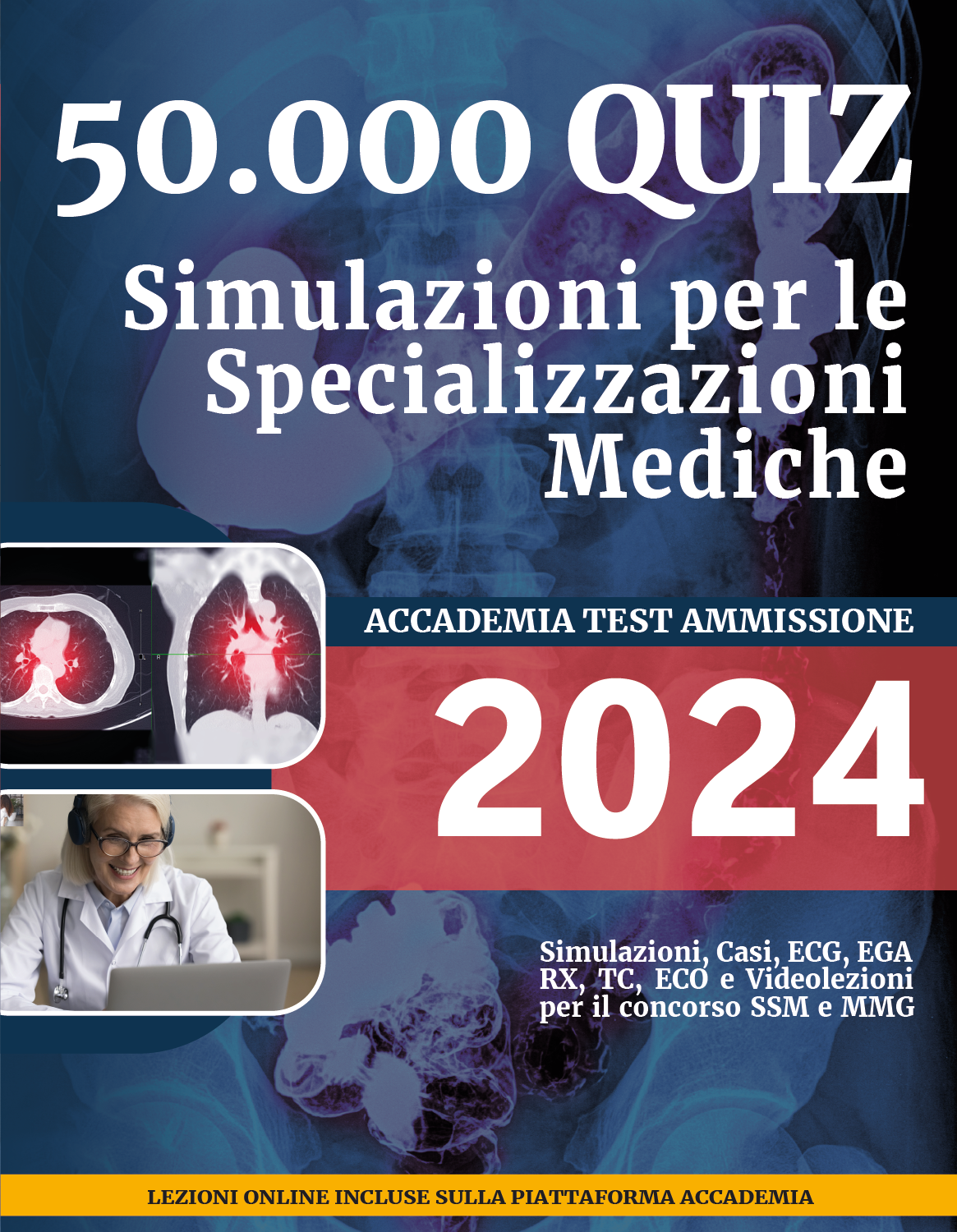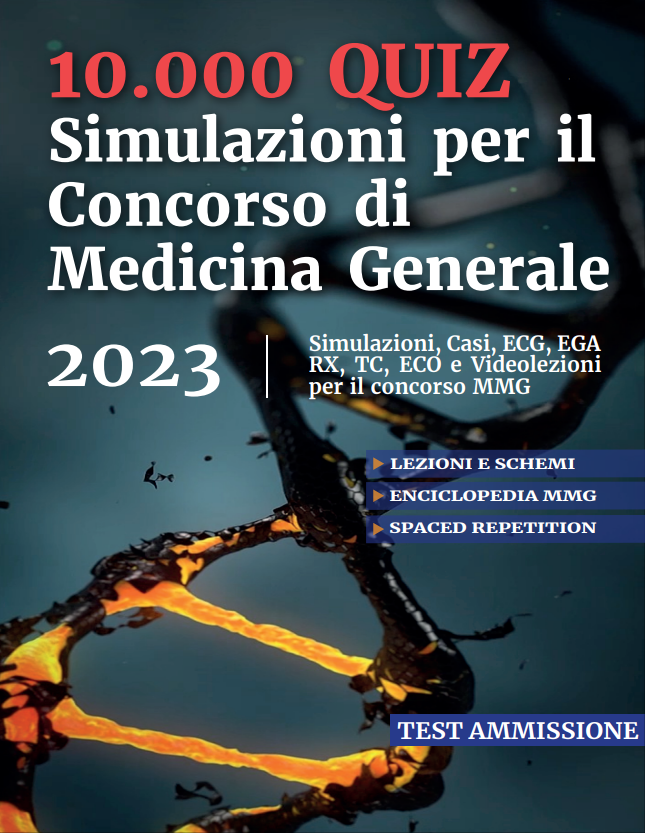La scintigrafia ossea è un esame diagnostico che permette, grazie alle caratteristiche di alcuni farmaci (detti radiofarmaci), di valutare il grado di attività metabolica dello scheletro (l’aumentata vascolarizzazione e l’aumentata attività osteoblastica). In modo abbastanza rapido, con una dose contenuta di radiazioni, e con alta sensibilità diagnostica, permette di evidenziare le aree in cui vi sia un aumentato turnover metabolico dell’osso. Al contrario rispetto all’alta sensibilità (le aree con alterazioni del metabolismo osseo sono evidenziabili alla scintigrafia molto prima che risultino evidenziabili radiologicamente), questo esame è dotato di bassa specificità poiché sono molteplici le condizioni in grado di indurre un aumento dell’attività osteoblastica, la quale provoca una maggiore concentrazione del radiofarmaco. Per questo motivo, in un percorso diagnostico o in un follow up, la scintigrafia è un esame che deve essere correlato ad altri esami radiologici o ad altre tecniche di imaging. A seconda del quadro scintigrafico ottenuto e naturalmente del quadro clinico-anamnestico del paziente, possiamo orientare il nostro sospetto diagnostico su una determinata patologia.
La scintigrafia ossea è un’ indagine medico-nucleare che permette di differenziare le aree osteoporotiche con ridotta attività osteoblastica e quindi ridotta captazione dalle aree osteomalaciche dove l’abbondante produzione di matrice osteoide induce un’ipercaptazione diffusa. La sensibilità delle tecniche medico-nucleari in questo caso è talmente alta che consente di identificare precocissimamente anche il solo rimaneggiamento osseo che produrrà una decalcificazione e quando evidente consentirà all’ imaging radiologico di evidenziarla. In questo tipo di esame vengono utilizzate delle gamma-camere e la somministrazione di un tracciante radioattivo che è costituito da un radioisotopo o da una molecola marcata con un radioisotopo. I traccianti possono essere sia omogenei che eterogenei: il tracciante può essere chimicamente identico alla sostanza tracciata (tracciante omogeneo), quindi con identica evoluzione spazio-temporale, oppure può avere in comune con la sostanza tracciata solo alcuni comportamenti di interesse (tracciante eterogeneo), eventualmente anche solo un’analoga distribuzione spaziale (tracciante di volume o di flusso). Nel caso della scintigrafia ossea vengono utilizzati i bifosfonati marcati con Tecnezio-99m (99mTc-HDP, 99mTc-MDP) che diffondono passivamente negli spazi extravascolari ed extracellulari e si depositano intorno alla matrice ossea permettendo di localizzare le aree scheletriche colpite dalla malattia.
Il principale meccanismo di legame dei fosfati sull’osso avviene per mezzo di legami chimici sulla superficie dei cristalli diidrossiapatite. Le grandi superfici di idrossiapatite, presenti nei centri di crescita o nelle lesioni ossee metabolicamente attive, mostrano maggiore capacità di concentrare il radiofarmaco.
La scintigrafia ossea permette pertanto di fare una valutazione del metabolismo dell’ osso e di eventuali alterazioni distrettuali del turnover metabolico ed una esplorazione contemporanea di tutti i distretti scheletrici, in breve tempo, con bassa irradiazione. E’ un esame dotato di elevata sensibilità diagnostica ed una bassa specificità , quindi è utile correlazione con esami radiologici (TC, RM) per definire la causa di ipercaptazione.
Andiamo a valutare le opzioni:
Il paziente descritto ha il morbo di Paget (risposta A corretta), detta anche osteite deformante, che è una patologia a carattere cronico con interessamento delle ossa e si caratterizza per un aumentato turnover osseo e nello specifico l’aumentata attività osteoclastica si associa ad un aumento compensatorio della attività osteoblastica, essendo responsabile di una struttura ossea pesantemente disorganizzata.
La malattia di Paget dell’osso è una patologia cronica dello scheletro dell’adulto in cui il turnover osseo è accelerato in alcune aree definite. La normale matrice è sostituita da osso indebolito e rarefatto. Distinguiamo due fasi: la prima di riassorbimento osseo focale, seguita da una fase di formazione ossea disordinata che provoca un rimodellamento anormale. Questo può portare alla graduale comparsa di dolore, deformità dei segmenti ossei interessati (spesso anche ingrandimento) ed eventuali fratture. I pazienti, che presentano una malattia di Paget potrebbero presentarsi anche dal medico dopo aver notato un aumento delle dimensioni della testa: spesso, colpisce il cranio, producendo un ispessimento anormale e irregolare dell’osso. Può essere colpito qualsiasi segmento osseo e quando vengono interessate le ossa lunghe, soprattutto degli arti inferiori, uno dei segni più evidenti è la curvatura di tali ossa. Abbiamo delle forme monostotiche e poliostotiche. I siti più interessati sono: pelvi 30-75%, femore 25-35%, rachide lombare 30-75%, cranio 25-65%, tibia 32%. Le estremità inferiori sono maggiormente interessate rispetto alle superiori. Il coinvolgimento cervicale e toracico è minore. (risposta corretta A)
Il sospetto di malattia di Paget si evince dalla storia di dolore osseo diffuso (anche se può decorrere in maniera del tutto asintomatica), dalla eventuale presenza di deformità scheletriche, dall’ incremento della circonferenza cranica e dai reperti osservati all’ esame obiettivo (come eminenze frontali e tibie ricurve). La diagnosi è effettuata con la RX che mostra una curvatura della tibia e del femore, ossa allargata con irregolarità del profilo, slargamento del cranio con aree radiotrasparenti (l’ Rx del cranio mostra il classico aspetto a “ fiocchi di cotone” ).
Dal punto di vista laboratoristico si apprezza un aumento della fosfatasi alcalina sierica e idrossiprolina urinaria, indicative di un aumento della degradazione del collagene nell’osso, mentre i livelli di calcio e fosfato sono nella norma. La maggior parte dei pazienti sono asintomatici e non richiedono trattamento, ma qualora fosse presenta una sintomatologia, essa solitamente comprende: dolore osseo, deformità scheletrica, fratture patologiche, deficit dei nervi cranici, ipoacusia secondaria all’espansione della volta cranica, insufficienza cardiaca severa ed una maggiore incidenza di aterosclerosi valvolare. La terapia può essere indicata al fine di trattare i sintomi e di prevenire le complicanze. Essa include in genere bisfosfonati, come alendronato, risendronato e pamidronato, che agiscono inibendo l’attività osteoclastica e rappresentano la terapia di prima linea per la malattia di Paget dell’osso.
Le metastasi ossee possono essere osteoaddensanti (dove abbiamo apposizione di matrice ossea per attvità osteoblastica incontrollata) e quindi radiocaptanti, osteolitiche (in cui l’osso viene eroso per aumento dell’attività osteoclastica) e quindi ipocaptanti, oppure miste con aree osteolitiche e osteoaddensanti. Nel K mammella le metastasi sono generalmente osteolitiche: gli osteoclasti vengono sovra attivati da parte di fattori tumorali (es. il peptide correlato al paratormone). Alla scintigrafia verranno quindi evidenziate aree ipocaptanti, “ fredde” (Risposta B errata). In altre neoplasie, come il K prostata, le metastasi sono invece osteoaddensanti e quindi ipercaptanti (eccessiva deposizione di osso osteoide con mineralizzazione, dovuta ad alterazioni della proliferazione ed attivazione osteoblastica da parte di alcuni fattori (endotelina 1).
Il linfoma è una delle neoplasie che metastatizzano più frequentemente alle ossa. A differenza del mieloma, sia nel caso del linfoma primitivo dell’osso sia di localizzazione secondaria, la scintigrafia ossea è sempre altamente positiva e permette di evidenziare eventuali localizzazioni scheletriche, diversa dalla localizzazione mostrata dalla scintigrafia presentata dove vi sono aree focali di iperaccumulo del tracciante, prevalentemente in corrispondenza dell’ arto inferiore di sinistra che si presenta come un’ area osteoaddensante e deformata. L’anamnesi e gli altri esami ematochimici e strumentali ci permetteranno di orientarci verso la diagnosi (risposta C errata).
L’ artrite reumatoide è una malattia cronica autoimmune ad eziologia sconosciuta, che coinvolge principalmente le articolazioni. Esordisce con sintomi articolari e sistemici come rigidità mattutina delle articolazioni interessate, astenia e malessere generalizzato ed affaticamento, mentre i sintomi articolari comprendono dolore, tumefazione e rigidità , fino ad arrivare a vere e proprie alterazioni articolari come le deformità a collo di cigno e a bottoniera.. Provoca infiammazione della sinovia e conseguente ipervascolarizzazione. L’aumento del flusso sanguigno, insieme al rimodellamento osseo, provoca una iperconcentrazione del farmaco. La scintigrafia ha un’alta sensibilità ma una bassa specificità . La localizzazione è maggiore nelle sedi tipiche della malattia quali mani (soprattutto le articolazioni metacarpo-falangee e interfalangee prossimali), i piedi, le ginocchia, la colonna cervicale (risposta D errata). Gli esami di laboratorio possono evidenziare positività del fattore reumatoide nell’ 80% dei casi; esso è un autoanticorpo che lega la frazione Fc delle immunoglobuline di tipo IgG, evidenziabile anche in altre patologie connettivali. Un marker diagnostico più specifico è rappresentato dalll’anticorpo anti-citrullina.