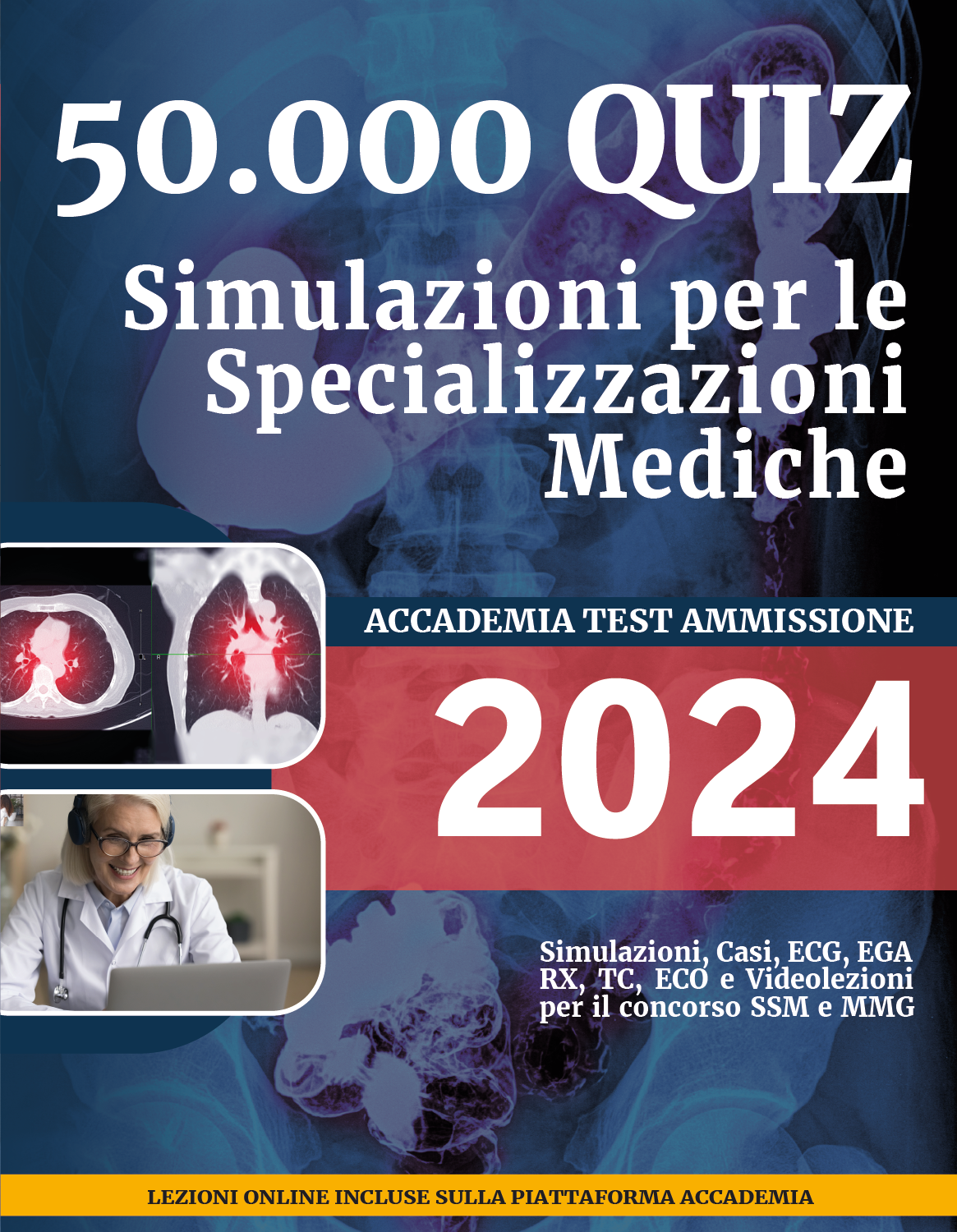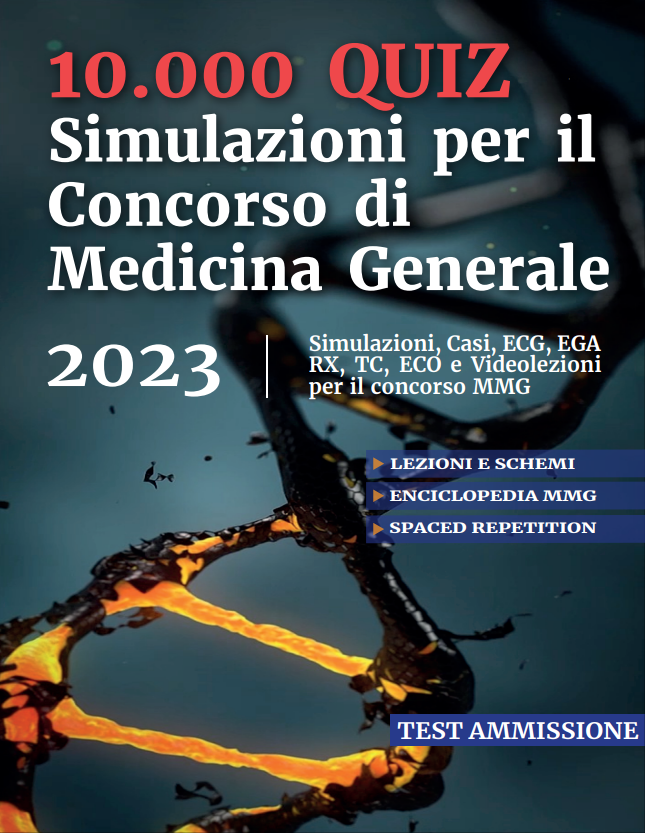La risposta corretta è la B.
La diagnosi più probabile per la paziente del caso clinico è la pitiriasi alba, una dermatosi benigna comune, che interessa principalmente i bambini e gli adolescenti con una maggiore prevalenza nel sesso maschile e nei pazienti con carnagione scura. In tale condizione la sintesi di melanina è normale, ma, a causa della rapida desquamazione dei cheratinociti che la contengono, si ha un suo deficit con ipopigmentazione cutanea. La pitiriasi alba si presenta tipicamente con più macule e chiazze ipo-pigmentate asintomatiche, rotonde o di forma ovale, che coinvolgono prevalentemente la faccia, il tronco superiore e gli arti superiori. Un lieve eritema può precedere lo sviluppo dell’ipopigmentazione. Tali lesioni sono asintomatiche, non essendo né dolenti, né pruriginose. La diagnosi è nella maggior parte dei casi semplice, basata sull’aspetto clinico e sulla distribuzione delle lesioni nei pazienti. Tale alterazione cutanea è una condizione patologica autolimitante e il trattamento con emollienti e corticosteroidi topici a bassa potenza può essere utile. Infine, gli inibitori topici della calcineurina possono essere un’alternativa ai corticosteroidi topici per il trattamento delle lesioni facciali.
Al contrario, la lebbra, una patologia infettiva, è causata dal Mycobacterium Leprae, germe acido-resistente, per il quale l’ uomo e l’ armadillo rappresentano il serbatoio infettivo. La trasmissione avviene per via aerea, ematogena e attraverso le secrezioni oro-nasali da soggetti infetti. La lebbra può essere classificata per tipo e numero di aree cutanee colpite:
-paucibacillare, quando presenta fino a 5 lesioni cutanee, senza batteri rilevati su campioni provenienti da tali zone;
-multi-bacillare, quando presenta più di 6 lesioni cutanee, con batteri rilevati su campioni di lesioni cutanee, o entrambi.
Può essere classificata anche in base alla risposta cellulare e riscontri clinici:
-tubercoloide, forma benigna meno diffusa e meno contagiosa con una forte risposta cellulo-mediata, che limita l’estensione della malattia a un paio di lesioni
cutanee;
-lepromatosa, infezione sistemica più grave, dove si manifesta in genere una scarsa immunità cellulo-mediata contro Mycobacterium Leprae con conseguente diffusa infiltrazione batterica della pelle, dei nervi, e di altri organi;
-borderline, caratterizzata dalla presenza di entrambe le caratteristiche delle forme tubercoloide e lepromatosa.
La biopsia cutanea rappresenta l’ esame gold standard per la diagnosi, dato che permette di osservare il processo flogistico a carico dei nervi coinvolti e di individuare la presenza di bacilli acido-resistenti (risposta A errata). All’ opposto, la tinea versicolor, un’ infezione causata dal fungo dimorfico Malassezia furfur, colonizza normalmente la pelle nella sua forma di lievito. Generalmente non causa la malattia in tale forma, ma, in alcuni individui si converte nella sua forma ifale (trasformazione in genere stimolata dall’ esposizione ad ambienti caldi, umidi e dall’ iperidrosi) e provoca lesioni caratteristiche, che consistono in chiazze desquamate multiple e asintomatiche con un colore che varia dal bianco al camoscio, al marrone, al rosa prevalentemente distribuite sul torace, sulle spalle e sulla schiena e solo raramente sul viso o sugli arti. Tale infezione fungina è superficiale, limitata alla cute e non contagiosa. La microscopia con preparazione del preparato cutaneo lesionale con idrossido di potassio (KOH) dimostrerà una confluenza di ife corte e forme di lievito rotondo (risposta C errata). Invece, la vitiligine, perdita dei melanociti cutanei con conseguente comparsa di aree di depigmentazione di dimensioni variabili, è verosimilmente un processo autoimmune con distruzione dei melanociti. Le regioni cutanee colpite si presentano come aree depigmentate, con totale assenza di melanociti o melanina residua. Dal punto di vista clinico, colpisce classicamente il dorso delle mani, i distretti periorifiziale ed i genitali, con evidenza di macchie depigmentate, che vengono meglio visualizzate mediante l’ esame con la lampada di Woods. Tutte caratteristiche non presenti nel caso clinico (risposta D errata).
Fonte Immagine: AMA Siegfried EC, Herbert AA. Diagnosis of Atopic Dermatitis: Mimics, Overlaps, and Complications. J Clin Med. 2015;4(5):884-917. Published 2015 May 6. doi: 10.3390/jcm4050884
MLA Siegfried, Elaine C and Adelaide a Hebert. “ Diagnosis of Atopic Dermatitis: Mimics, Overlaps, and Complications” Journal of clinical medicine vol. 4,5 884-917. 6 May. 2015, doi: 10.3390/jcm4050884
APA Siegfried, E. C., & Hebert, A. A. (2015). Diagnosis of Atopic Dermatitis: Mimics, Overlaps, and Complications. Journal of clinical medicine, 4(5), 884-917. doi: 10.3390/jcm4050884