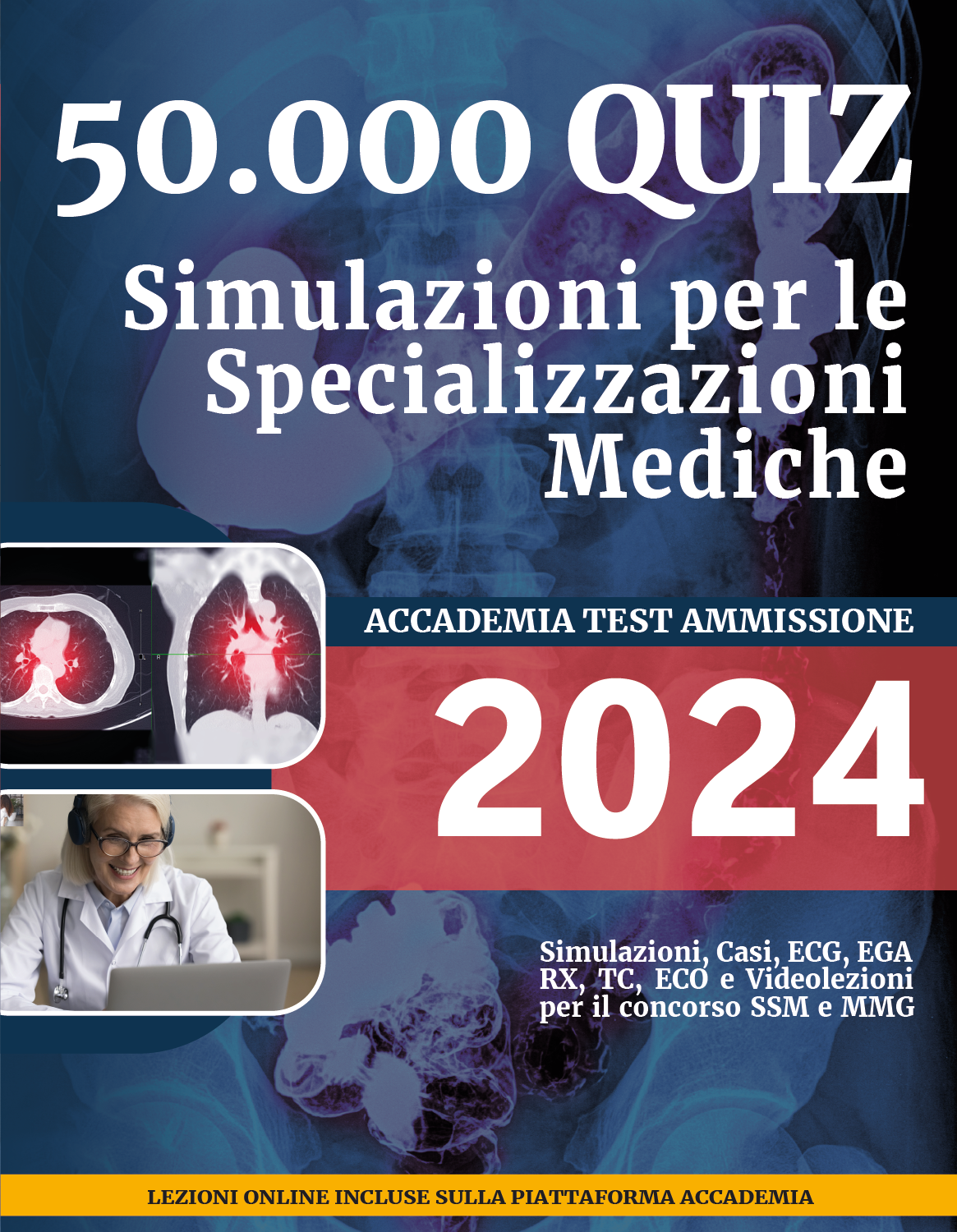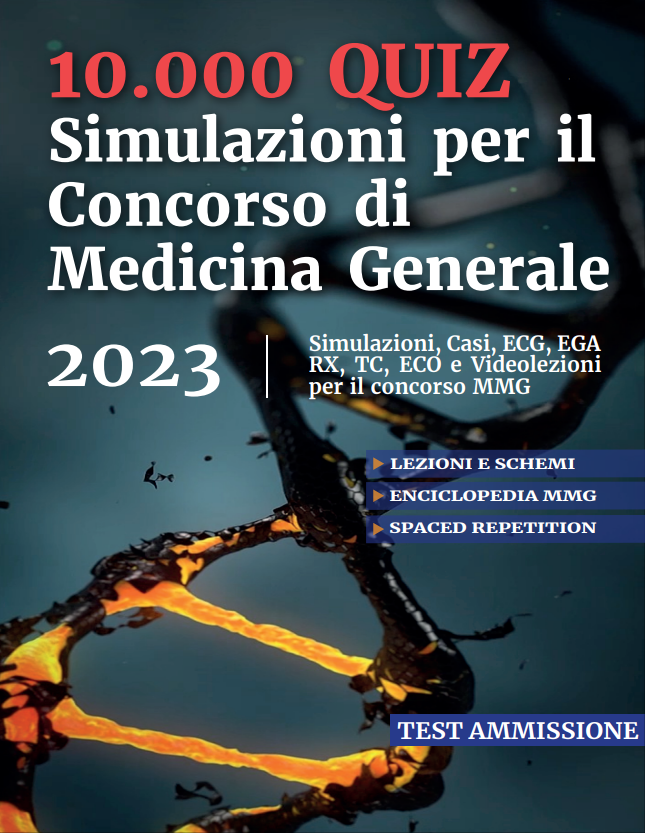La risposta D è corretta.
Il paziente circa 10 anni fa si era sottoposto a un intervento di sostituzione protesica con impianto di protesi valvolare suina per severo rigurgito mitralico. Il trattamento di una valvulopatia, a meno che non sia di grado medio-elevato e clinicamente significativa, richiede solo un controllo periodico, mentre l’intervento chirurgico è indicato in presenza di una lesione moderata o grave responsabile di sintomi e/o disfunzione cardiaca. Le opzioni vanno dalla valvuloplastica alla riparazione fino alla sostituzione, che può essere effettuata con protesi meccaniche (preferite nei pazienti <65 anni o con lunga aspettativa di vita, ma richiedono anticoagulazione cronica con warfarin per prevenire tromboembolismo) o biologiche (suine o bovine, più soggette a deterioramento sclero-fibrotico, con durata media 10-15 anni). Una complicanza possibile delle protesi biologiche è l’ostruzione/stenosi o il rigurgito, entrambi responsabili di scompenso cardiaco.
L’endocardite infettiva insorge in presenza di una predisposizione endocardica (patologie congenite, reumatiche, valvole bicuspidi calcifiche, prolasso mitralico, cardiomiopatia ipertrofica, precedente endocardite). Fattori predisponenti sono protesi valvolari, tossicodipendenza, diabete, uso cronico di anticoagulanti o steroidi, età avanzata. Agenti più comuni sono streptococchi e stafilococchi (80-90%), seguiti da enterococchi e microrganismi HACEK. Clinicamente si manifesta con febbre, nuovo soffio o modifica di un soffio preesistente, può causare scompenso cardiaco e, all’ecocardiogramma, vegetazioni. Segni caratteristici: petecchie congiuntivali, macchie di Roth, lesioni di Janeway, nodi di Osler, emorragie subungueali a scheggia. La diagnosi si basa sui criteri di Duke (diagnosi rigettata, possibile o certa). In assenza di emocolture disponibili, e senza rischio per MRSA, la terapia empirica si effettua con un β-lattamico + amminoglicoside. Sebbene questo paziente presenti soffio e segni di scompenso, non ha febbre né criteri di Duke: l’endocardite è improbabile (risposta A errata).
La BPCO è una malattia polmonare cronica non reversibile, con ostruzione bronchiale persistente (VEMS/CVF <0,7), spesso correlata a fumo e caratterizzata da progressione, riacutizzazioni infettive, dispnea, tosse produttiva cronica, tachipnea, cianosi e ipertensione polmonare nelle fasi avanzate. All’auscultazione: respiro sibilante e fase espiratoria prolungata. Nonostante il paziente sia fumatore con tosse, i sintomi durano solo da 3 settimane e non vi sono segni obiettivi di ostruzione: la diagnosi di BPCO è errata (risposta B errata).
La polmonite è un’infiammazione acuta polmonare (batterica, virale, fungina, parassitaria) diagnosticata con RX torace e reperti clinici. Può essere comunitaria (più spesso da Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) o nosocomiale. Clinicamente: febbre, tosse, dispnea, astenia, ipossia; nella forma tipica: esordio acuto con febbre, tosse produttiva, crepitii e rumori bronchiali; nella forma atipica: esordio graduale con tosse secca, dispnea e pochi segni obiettivi. È indicato esame colturale di sangue/escreato. Questo paziente presenta tosse produttiva ma non febbre, e all’auscultazione rantoli basali bilaterali: più compatibili con scompenso cardiaco che con polmonite (risposta C errata).
L’embolia polmonare è occlusione di arterie polmonari da trombi (arti inferiori/pelvi). Presentazione acuta con sintomi aspecifici: dolore toracico pleuritico, tosse, sincope, dispnea, arresto cardiorespiratorio nei casi gravi; segni: tachipnea, tachicardia, ipotensione. Fattori di rischio: immobilizzazione, trombofilie, gravidanza, chirurgia recente. In questo paziente tosse e dispnea possono mimarla, ma anamnesi negativa per immobilizzazione e presenza di stenosi mitralica con edemi declivi bilaterali fanno propendere per scompenso cardiaco congestizio piuttosto che embolia polmonare (risposta E errata).