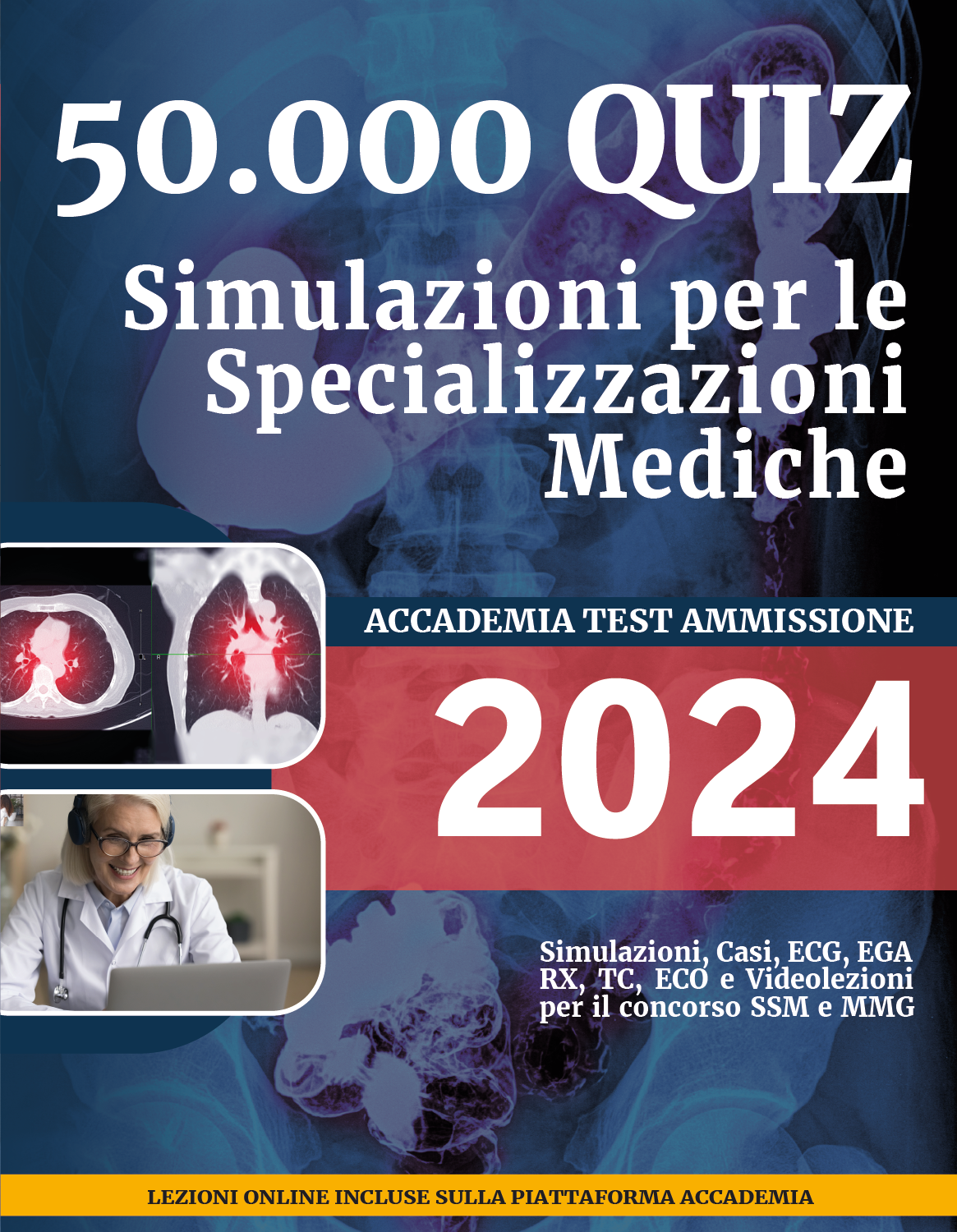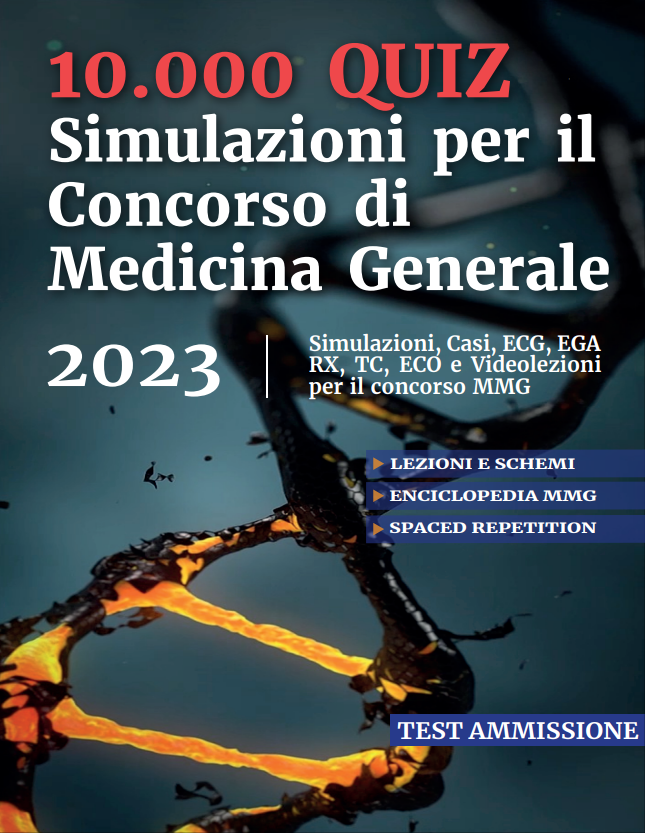La risposta corretta è la B.
La soluzione del problema in questione richiede la comprensione della definizione della forza magnetica, la quale è espressa mediante la formula F = iL x B. In tale espressione, il simbolo x indica il prodotto vettoriale, mentre L è un vettore avente la stessa direzione e verso della corrente i, ed è lungo quanto il filo. B rappresenta invece il campo magnetico al quale il corpo in esame è soggetto. Focalizzandosi esclusivamente sul modulo della forza magnetica, si ottiene l'espressione F = iLB sin(angolo tra il filo e il campo magnetico). È importante sottolineare che il valore massimo del seno di un angolo (pari a 1) viene raggiunto quando l'angolo in questione è di 90°, ovvero quando il filo e il campo magnetico risultano ortogonali (la risposta B è corretta). Di conseguenza, la forza magnetica risulterà massima quando il campo magnetico è perpendicolare al filo, mentre sarà nulla quando l'angolo tra il filo e il campo magnetico è pari a 0°, 180° o 360°. È importante evidenziare che, poiché la corrente fluisce parallelamente al filo, la risposta corretta al quesito posto è "Quando il campo magnetico B è ortogonale alla corrente". Questo perché, se il campo magnetico risulta essere perpendicolare al filo, allora sarà anche perpendicolare alla corrente, e viceversa.