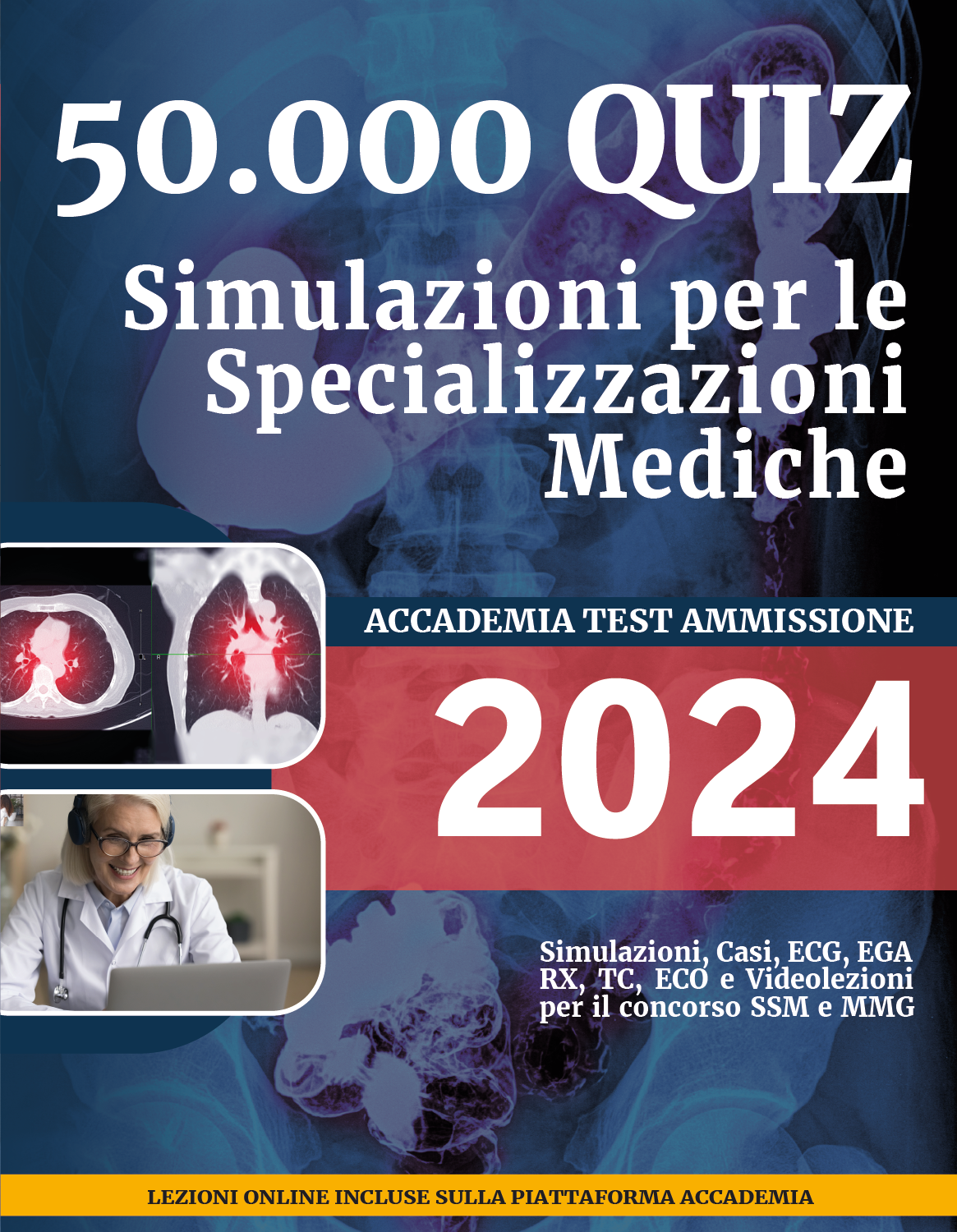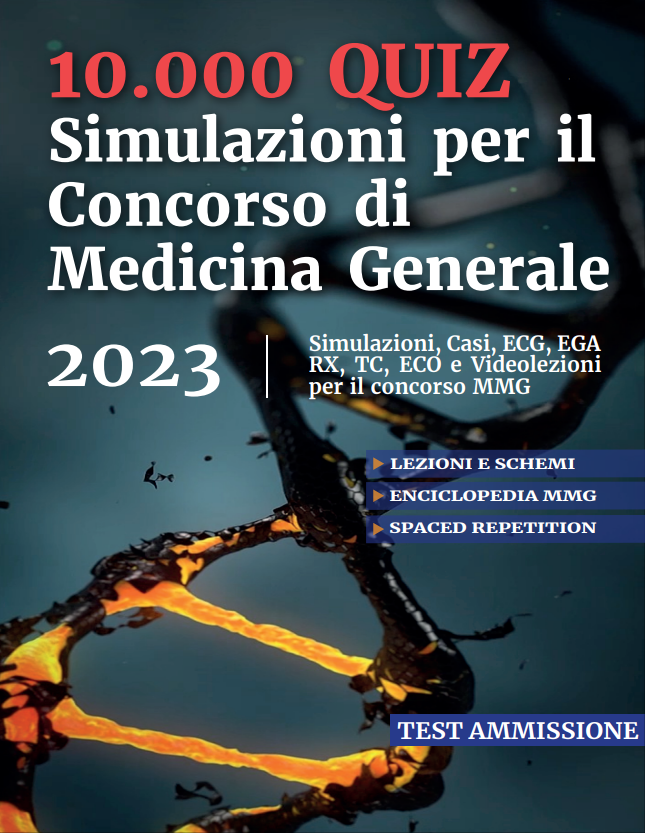La risposta corretta è la B.
La regola di Hund, o la massima molteplicità di spin, è una legge che regola il riempimento degli orbitali degeneri in un atomo o in una molecola. Questa regola afferma che, quando ci sono orbitali degeneri, gli elettroni sono prima disposti in modo che ciascun orbitale degeneri contenga un solo elettrone con spin parallelo, fino a raggiungere il semiriempimento di tutti gli orbitali degeneri. Solo successivamente, gli elettroni iniziano ad accoppiarsi e formare doppietti elettronici. Nel diagramma fornito, si osservano tre orbitali degeneri di tipo p. Nell'esempio 1, la regola di Hund non viene rispettata perché tre elettroni sono disposti in un doppietto e un singoletto, invece di essere disposti come tre doppietti. Nell'esempio 2, la regola di Hund viene rispettata poiché ci sono tre singoletti con spin parallelo. Nell'esempio 3, la regola di Hund non viene rispettata poiché ci sono quattro elettroni disposti come due doppietti, invece di essere disposti come un doppietto e due singoletti. Nell'esempio 4, la regola di Hund non viene rispettata poiché i tre singoletti non hanno tutti spin parallelo. Nell'esempio 5, la regola di Hund viene rispettata poiché il blocco p è completamente riempito con tre doppietti. Pertanto la risposta corretta è la B.